Il termine sovranità alimentare si è riempito di significato così come ha dato origine a dibattiti, interrogativi, contributi da prospettive, culture e fasi diverse. È stato costruito dalla pratica della mobilitazione e della resistenza, dal Nord e dal Sud, accogliendo altre lotte come il femminismo o la difesa del territorio, che l'hanno arricchito e ampliato. Può coincidere con la sovranità energetica? E' possibile comprendere entrambi i paradigmi dalle loro esperienze e proposte?
Con l'obiettivo di provocare questo incontro, abbiamo proposto a Pablo Bertinat di dare voce alla sovranità energetica. Pablo è coordinatore dell'Osservatorio dell'Energia e della Sostenibilità dell'UTN (Università Tecnologica Nazionale, Argentina) e membro del comitato di redazione della Rivista Energía y Equidad, che si propone di “approfondire l'analisi e la critica dell'attuale modello energetico e contribuire alla costruzione di alternative regionali e locali al modello di sviluppo egemonico, in stretta connessione con le lotte che si stanno svolgendo nella regione per rendere possibile un altro modello di società”. Ci è sembrato inoltre che fosse necessario avere un punto di vista dall'America Latina, continente che fornisce gran parte dei materiali necessari alla costruzione di infrastrutture per l'utilizzo delle cosiddette energie rinnovabili.
"L'alimentazione fuori dall'OMC" e "Gli alimenti non sono merce" sono stati alcuni slogan chiave di La Via Campesina. La sovranità alimentare nasce dal conflitto, da uno scontro di modelli, ed è evidente il suo rifiuto del modello capitalista.
SABC: La sovranità energetica contempla questa logica anticapitalista?
Rivista Energia ed Equità: Innanzitutto devo dire che, come si vedrà in questo dialogo, abbiamo imparato molto dalle lotte contadine, perché sono una grande fonte di ispirazione e ci sentiamo parte di esse. E, sì, il nostro sguardo e la nostra azione riguardo alla transizione energetica si collocano all'interno del percorso di modifica dei rapporti di produzione esistenti. È uno sguardo post-capitalista, che si manifesta anche in un contesto di esauribilità di risorse e bacini e di disuguaglianza senza limiti.
Intendiamo infatti l'energia come parte dei beni comuni e, in tal senso, come parte dei diritti collettivi in coerenza con i diritti della natura. L'energia è uno strumento e non un fine in se stesso. Ci sforziamo anche di costruire una visione dell'energia come un diritto, prendendo come esempio le lotte per il diritto all'acqua e assumendo che i diritti sono costruzioni sociali. Questo processo dovrebbe essere associato alla demercificazione del settore energetico.
Nel primo caso c'interessa pensare al diritto come prerogativa della totalità degli esseri viventi, non solo degli esseri umani. In questa definizione incorporiamo la natura con tutte le sue specie. Riteniamo fondamentale che i loro diritti siano preservati e rispettati per l'esercizio di una vita dignitosa, presente e futura, perché esiste un'interdipendenza tra il pieno godimento della vita umana e l'ambiente.
D'altra parte, la de-mercificazione presuppone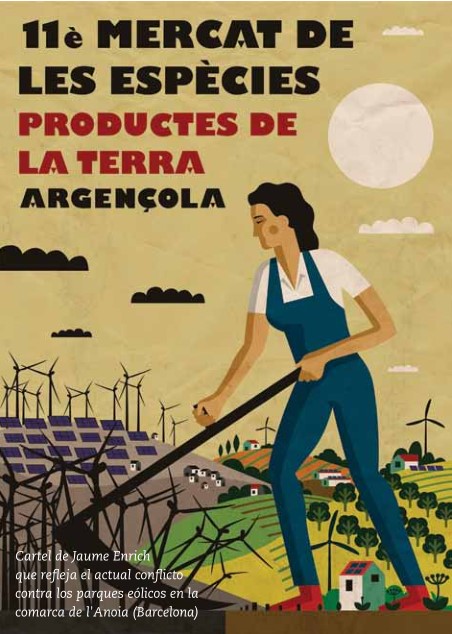 l'accettazione che, nel quadro dell'attuale sistema capitalistico, i mercati siano strumenti al servizio di settori la cui logica è l'accumulazione di capitale senza limiti, anche al di là delle considerazioni sui limiti fisici o sulla vita. I mercati non sono luoghi neutrali in cui tutti gli agenti che intervengono hanno la stessa conoscenza e accesso all'informazione.
l'accettazione che, nel quadro dell'attuale sistema capitalistico, i mercati siano strumenti al servizio di settori la cui logica è l'accumulazione di capitale senza limiti, anche al di là delle considerazioni sui limiti fisici o sulla vita. I mercati non sono luoghi neutrali in cui tutti gli agenti che intervengono hanno la stessa conoscenza e accesso all'informazione.
Affinché questo sistema si diffondesse come ha fatto, è stato necessario che il mercato capitalista avanzasse e colonizzasse le sfere non mercificate. Intendiamo che il concetto di demercificazione disputa la centralità dei mercati per risolvere i bisogni.
SABC: Dici di aver imparato molto dalle lotte contadine. A questo proposito, la sovranità alimentare ingloba fin dalle sue origini la lotta alla fame nel Mezzogiorno. In questa prospettiva di giustizia sociale, la fame è uguale alla povertà energetica? C'è un approccio simile dalla sovranità energetica?
REE: Negli ultimi 150 anni, mentre la popolazione del pianeta si è moltiplicata per 5,5, la produzione di energia si è moltiplicata per 50. Nonostante ciò, nel mondo sono circa 800 milioni le persone che non hanno accesso all'elettricità e circa 2 miliardi che cucinano con biomassa in condizioni che danneggiano la loro salute. A questo bisogna aggiungere i milioni di persone che nelle statistiche appaiono con accesso all'energia, ma in condizioni indegne, non sicure, ecc. Questo perché il sistema energetico, come quello alimentare, è pensato per fare affari e non per migliorare la qualità della vita delle persone.
Nel corso della storia, sono stati diversi i momenti in cui si sono verificati cambiamenti nel rapporto tra il sistema energetico e la società. L'apparizione dell'agricoltura ha significato un salto di qualità nell'uso dell'energia; l'uso del lavoro degli schiavi e degli animali fu un altro; e la rivoluzione industriale con i combustibili fossili è stato il più recente. Al momento la realtà è un'altra, i combustibili fossili stanno per finire, anche se ora dobbiamo abbandonarli a causa degli impatti che producono sul territorio e sul clima. Le fonti rinnovabili sono inesauribili in termini di fonte, ma per il loro utilizzo richiedono materiali e minerali scarsi sul pianeta. Nasce quindi l'esigenza di una transizione verso un sistema socio-ambientale ed economico con meno materia ed energia, il che è più complesso nell'attuale contesto di forte disuguaglianza globale sopra descritto.
È chiaro che molte persone dovranno consumare meno energia, altre probabilmente avranno bisogno di consumarne di più, ma l'intera popolazione dovrà consumare in modo diverso. C'è un bisogno ineludibile di lavorare sui processi di costruzione del desiderio e di mettere in discussione la cultura dominante di accumulazione di beni materiali ed energia per raggiungere la felicità. È un processo difficile in un contesto di sconfitta rispetto alle abitudini egemoniche, ma si possono costruire alternative.
SABC: Ottocento milioni di persone senza elettricità, così come ottocento milioni di persone senza accesso al cibo: paralleli terribili tra due sovranità violate. Per quanto riguarda le alternative, che percorso avete fatto per reimparare le tecnologie contadine o rurali nella produzione di energia con sistemi locali, appropriati, che non dipendano da multinazionali e materiali di altri territori? Ci vengono in mente i mulini, la trazione animale, le piccole turbine idrauliche, la legna da ardere...
REE: Questo argomento è estremamente importante. Tendiamo ad avere uno sguardo contraddittorio. Da un lato, la resistenza ai progetti energetici predatori è molto forte; ma, dall'altra è difficile per noi superare l'immagine costruita dalla scienza moderna che considera le proposte dei settori popolari come opzioni inferiori, vetuste, inefficienti o molto locali, che non si applicano a una dimensione globale.
C'è da mettere in chiaro che la tecnologia da sola non risolve alcun problema, ma che la società e la tecnologia – gli attori sociali e gli artefatti e sistemi - interagiscono e si costruiscono a vicenda. Come afferma Hernán Thomas, dell'Università Nazionale di Quilmes, “le tecnologie sono costruzioni sociali tanto quanto le società sono costruzioni tecnologiche. Per questo si parla di sociotecnico». Comprendendo quindi che le tecnologie sono molto più che artefatti, ci sembra importante nel campo della transizione energetica, pensare a soluzioni tecnologiche che contribuiscano a risolvere i problemi sociali, avanzare in alternative di generazione distribuita ed equa di benefici, apprendimento collettivo e dialogo di saperi, riconoscendo esperienze e saperi tradizionali, lavoro collaborativo, controllo socializzato, parità di diritti, miglioramento della qualità della vita. Le decisioni e i processi non possono essere lasciati nelle mani degli "esperti". Sovranità significa anche che la popolazione deve avere la possibilità di partecipare alla progettazione di tecnologie che si riverberano sull'interesse pubblico e alla definizione di politiche pubbliche che finanziano la scienza e regolano le tecnologie.
Credo che vadano tenute in considerazione le tecnologie tradizionali, ma senza trascurare i nuovi progressi scientifico-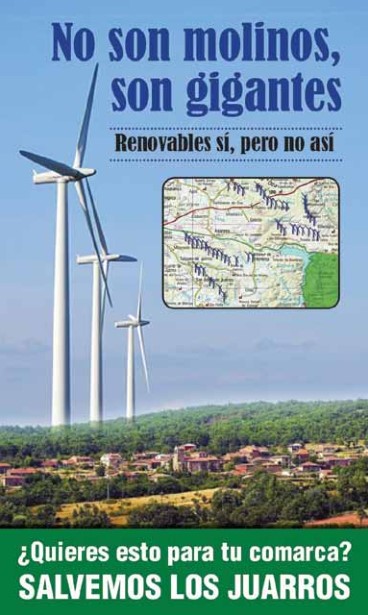 tecnologici, come l'energia eolica, il solare fotovoltaico, il solare termico, il solare passivo, ecc. In ogni caso, come dicevamo, non si tratta solo di dispositivi, ma di un processo di costruzione sociale della tecnologia.
tecnologici, come l'energia eolica, il solare fotovoltaico, il solare termico, il solare passivo, ecc. In ogni caso, come dicevamo, non si tratta solo di dispositivi, ma di un processo di costruzione sociale della tecnologia.
SABC: E come si rendono compatibili questi progressi con la finitezza dei materiali su cui poggiano?
REE: È che la limitatezza dei materiali e dei bacini impatta su tutte le tecnologie; naturalmente, secondo l'intensità del caso. La difficoltà che presenta la transizione energetica di cui abbiamo bisogno è che stiamo andando verso un futuro con meno disponibilità di energia e materiali, cosa che non è mai avvenuta nella storia o, se è avvenuta, ha comportato veri e propri collassi.
Il sistema energetico è un insieme di relazioni sociali che lega le persone come specie alla natura e che è determinato dai rapporti di produzione. La transizione energetica popolare e la sovranità energetica richiedono lo sviluppo di nuove relazioni sociali, di produzione e con la natura. Nei movimenti contadini e agroecologici si è sviluppata l'importanza di ri-localizzare l'economia e questo ci ha portato a parlare, per esempio, di circuiti corti o di cibo a chilometro zero. E andiamo ancora oltre: vediamo che l'attuale vita urbana si scontra con le leggi della natura ed è per questo che si parla anche di 'ruralizzare' le nostre modalità di vita, di invertire l'attuale disequilibrio demografico urbano-rurale.
SABC: Come prospettate dalla sovranità energetica popolare la decentralizzazione dell'energia?
REE: Siamo d'accordo con le visioni che riguardano circuiti corti di produzione e non solo degli alimenti, ma semmai da un punto di vista generale di approvvigionamento. Questo è un grande punto di coincidenza tra le visioni delle sovranità.
Siamo anche d'accordo che la sfida più grande si dà nei contesti urbani e per molteplici ragioni. I cambiamenti negli stili di vita indotti dall'urbanizzazione non si riferiscono solo al consumo, ma anche a pratiche di collaborazione, solidarietà o cooperazione, che sono fortemente indebolite nei contesti urbani. Ma il problema più grande, da un punto di vista energetico, è probabilmente la realizzazione di opere pubbliche, che di per sé consumano quantità di energia spropositate. La sostenibilità energetica delle grandi città non è percorribile nell'attuale contesto di risorse limitate, cambiamenti climatici e disuguaglianze. L'unico modo possibile è ridurre la complessità delle reti urbane, sia dal punto di vista materiale che organizzativo.
Decentralizzare è congruente al deconcentrare e democratizzare. Non è un problema tecnico o solo tecnico, è politico. Avendo chiaro ciò, la questione dell'habitat è centrale, poiché tutto ciò che è infrastruttura che può durare decenni o secoli, stabilisce un piano di consumo e anche di benessere. E questo può essere prospettato anche a partire da fonti rinnovabili, che sono distribuite e decentralizzate, e che ci permettono di costruire modalità di vita per raggiungere la felicità con meno materia ed energia.
* Traduzione di Giorgio Tinelli per Ecor.Network
Tratto da:
Revista Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas
"Ruralismo frente a capitalismo energético"
N°41, Verano 2021 - 56 pp.
Download:
