
Una nuova città vista attraverso il prisma dei diritti della Natura
Tenendo conto che stiamo trattando il costituzionalismo urbano e superando le strette logiche delle semplici amministrazioni municipali, la domanda che ci poniamo riguardo ai Diritti della Natura, e certamente anche ai Diritti Umani, è come raggiungere i più alti livelli di sostenibilità e di equità sociale nelle città. La risposta richiede esercizi di radicalizzazione permanente della democrazia, visto che rifiutiamo categoricamente qualsiasi opzione autoritaria.
Quindi, a questo punto, recuperando soprattutto la forza dell’azione comunitaria – cioè dal basso – forse è giunto il momento di dare impulso alla costruzione di Costituzioni Urbane. Non si tratta di semplici statuti autonomi da applicare dall’alto. Sarebbero una sorta di strumenti politici per ripensare e trasformare le città, disputando il potere dal basso sia agli organi governativi tradizionali che ai potenti gruppi di potere economico – legale e illegale – che controllano in gran parte la vita delle città.
Ma prima chiariamo la portata di questo tanto ritrito concetto, la sostenibilità, visto che oggi tutti ne parlano. Il termine fiorisce in ogni dove. Il suo utilizzo indiscriminato ha fatto sì che (quasi) tutto possa essere classificato come sostenibile, superando o addirittura ignorando l’origine profonda del termine. Di più, vengono definite sostenibili anche questioni che in sostanza non lo sono, né possono esserlo. Si parla di crescita economica sostenibile, quando è ovvio che in un mondo con limiti biofisici definiti, una crescita permanente nel tempo, cioè sostenibile, risulta impossibile. Si continua senza alcuna remora a promuovere lo sviluppo sostenibile, un doppio ossimoro. Forse la più grande di queste aberrazioni emerge quando si parla di estrazione mineraria o di sfruttamento del petrolio sostenibili. Ed è ancora una pura manipolazione dello stesso termine, il tentativo di presentare come sostenibile la generazione di elettricità utilizzando combustibili fossili o anche attraverso altre fonti energetiche che, come le grandi dighe idroelettriche, possono causare enormi impatti ambientali. Qualcosa di simile accade in molti casi con altre energie “pulite” che si basano s'una crescente domanda di minerali; o come l’energia eolica, che provoca massicci processi di deforestazione nelle foreste tropicali a causa dell’utilizzo del legno di balsa (VV.AA., 2021). Qualcosa di simile accade in molte occasioni con altre energie “pulite” che si basano su una crescente domanda di minerali; o come l’energia eolica, che provoca massicci processi di deforestazione nelle foreste tropicali a causa dell’utilizzo del legno di balsa (VV.AA., 2021).
ritrito concetto, la sostenibilità, visto che oggi tutti ne parlano. Il termine fiorisce in ogni dove. Il suo utilizzo indiscriminato ha fatto sì che (quasi) tutto possa essere classificato come sostenibile, superando o addirittura ignorando l’origine profonda del termine. Di più, vengono definite sostenibili anche questioni che in sostanza non lo sono, né possono esserlo. Si parla di crescita economica sostenibile, quando è ovvio che in un mondo con limiti biofisici definiti, una crescita permanente nel tempo, cioè sostenibile, risulta impossibile. Si continua senza alcuna remora a promuovere lo sviluppo sostenibile, un doppio ossimoro. Forse la più grande di queste aberrazioni emerge quando si parla di estrazione mineraria o di sfruttamento del petrolio sostenibili. Ed è ancora una pura manipolazione dello stesso termine, il tentativo di presentare come sostenibile la generazione di elettricità utilizzando combustibili fossili o anche attraverso altre fonti energetiche che, come le grandi dighe idroelettriche, possono causare enormi impatti ambientali. Qualcosa di simile accade in molti casi con altre energie “pulite” che si basano s'una crescente domanda di minerali; o come l’energia eolica, che provoca massicci processi di deforestazione nelle foreste tropicali a causa dell’utilizzo del legno di balsa (VV.AA., 2021). Qualcosa di simile accade in molte occasioni con altre energie “pulite” che si basano su una crescente domanda di minerali; o come l’energia eolica, che provoca massicci processi di deforestazione nelle foreste tropicali a causa dell’utilizzo del legno di balsa (VV.AA., 2021).
A quanto sappiamo, alcune città vengono presentate come sostenibili, o aspirano a esserlo. Sappiamo bene che l’impronta ecologica di qualsiasi città supera di gran lunga la superficie urbanizzata, che per definizione, tenendo conto dei diritti della natura, lascerebbe tutte quelle città fuori dalla pretesa di sostenibilità. Tuttavia, vale la pena ridurre i livelli di insostenibilità, quasi sempre molto elevati (Acosta, 2027).
Di fatto, il significato profondo della sostenibilità è stato vampirizzato. Il suo utilizzo si adatta agli interessi più diversi, in particolare all’accumulazione del capitale. La sostenibilità è diventata un mero jolly, come molti altri jolly del feticismo capitalista, che - tra l’altro - sembra avere proprio la capacità di vampirizzare qualsiasi concetto che tenti di opporsi alla civiltà del capitale.
Se per definizione non esistono città sostenibili, la questione è come nelle città tradurre in pratica la rivendicazione che la Natura richiede come soggetto di diritti. Non si tratta di cedere il passo a soluzioni come quelle prodotte dalla migrazione degli abitanti benestanti verso altre zone vicine alle città meno inquinate, e ancor meno dallo svuotamento violento delle città, come ha tentato Pol Pot in Cambogia. Si tratta di recuperare livelli e spazi di razionalità ecologica, riducendo - ad esempio - le emissioni di gas serra, promuovendo un sistema di trasporto pubblico sostenibile, riducendo il rumore, minimizzando la domanda di risorse naturali, riducendo sostanzialmente i rifiuti, garantendo il massimo livello di offerta di energia pulita, eliminando l’uso di materiali inquinanti, espandendo la domanda di materiali riutilizzabili, rioccupando terreni e case disabitati, garantendo la fornitura di acqua potabile e la gestione delle acque reflue in condizioni ambientalmente ragionevoli, promuovendo il riciclaggio dei materiali di scarto, ottenendo una crescente sovranità energetica nelle città, la gestione responsabile dei rifiuti,[10] espandendo gli spazi verdi anche come chiave per i processi di sovranità alimentare, promuovendo l’educazione e la consapevolezza ecologica, creare le condizioni per l’espansione del tempo libero creativo. Queste e molte altre azioni richiedono, allo stesso tempo, un sostanziale miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne: condizione fondamentale per fermare l’incessante e massiccia migrazione dalle campagne alle città.
Tutto questo nella chiave della giustizia sociale e della democrazia radicale, come base per una vita dignitosa per tutti gli abitanti: senza questi requisiti/obiettivi fondamentali, qualsiasi preoccupazione esclusivamente ambientale diventa un semplice esercizio di giardinaggio.
 Nel 1967, Henri Lefebvre, nel suo libro Il diritto alla città (1969, ed. spagnola), [11] analizzo le città trasformate in beni al servizio esclusivo degli interessi dell’accumulazione del capitale. Questa realtà, secondo lui, ha portato a un processo accelerato di commercializzazione urbana che, tra le altre questioni da tenere in considerazione, ha trasformato la terra sempre più in oggetto di speculazione. Di fronte a questo fenomeno, recuperando il diritto alla città, si è proposto di costruire una controproposta politica che rivendicasse la possibilità che gli abitanti della città tornassero a impadronirsi della città stessa, costruendo opzioni di vita dignitose a partire dal proprio territorio, comunità o quartiere. Nella fallita Carta Magna del Cile, questa questione era espressa chiaramente nell'articolo 52.1:
Nel 1967, Henri Lefebvre, nel suo libro Il diritto alla città (1969, ed. spagnola), [11] analizzo le città trasformate in beni al servizio esclusivo degli interessi dell’accumulazione del capitale. Questa realtà, secondo lui, ha portato a un processo accelerato di commercializzazione urbana che, tra le altre questioni da tenere in considerazione, ha trasformato la terra sempre più in oggetto di speculazione. Di fronte a questo fenomeno, recuperando il diritto alla città, si è proposto di costruire una controproposta politica che rivendicasse la possibilità che gli abitanti della città tornassero a impadronirsi della città stessa, costruendo opzioni di vita dignitose a partire dal proprio territorio, comunità o quartiere. Nella fallita Carta Magna del Cile, questa questione era espressa chiaramente nell'articolo 52.1:
Il diritto alla città e al territorio è un diritto collettivo orientato al bene comune e si fonda sul pieno esercizio dei diritti umani sul territorio, sulla sua gestione democratica e sulla funzione sociale ed ecologica della proprietà.
Sono quindi necessarie una riflessione e una critica finalizzate alla costruzione di altre città che servano da base per altri mondi in cui tutti gli esseri viventi – umani e non umani – vivano con dignità. È quindi evidente, se accettiamo il mandato chiave dei Diritti della Natura, che il superamento dell’antropocentrismo è una delle sfide più importanti che abbiamo tra le mani, poiché ci chiama a percorrere sentieri di post-sviluppo, post-estrattivismo, nonché di post-decrescita economica (Acosta et al., 2021).
Contrariamente alle letture convenzionali, “le luci della città” hanno illuminato forme rinnovate di dominazione coloniale, patriarcale, clericale, persino geografiche…alimentando le illusioni di “progresso” e “sviluppo”: fantasmi impossibili da raggiungere, per i più.
Un punto di partenza da considerare: le città sperimentano una disconnessione (quasi) permanente dai ritmi della Natura. Questa disconnessione si sta accelerando sempre più con il crescente numero di abitanti nel mondo concentrati nelle città: nel 2007 la popolazione urbana ha superato quella rurale: si prevede che entro il 2050 due terzi dell’umanità vivrà nelle città. D'altro canto le città si nutrono di un saccheggio sempre crescente della Natura: ad esempio, vediamo quanti minerali o alimenti sono necessari per sostenere la vita nelle città e quali sono gli impatti causati dall'attività mineraria, dal petrolio e dalle monocolture, per citare solo un paio di casi.
La cosa grave è che i settori dominanti hanno bisogno di sostenere questi estrattivismi di saccheggio per accedere ai servizi e ai benefici che la vita offre, poiché, come conclude Mario Rodríguez Ibáñez (2018), “la città coloniale ha stabilito nell’immaginario collettivo che la civiltà, la superiorità, si vivono nelle città”. Ciò ha causato un passaggio di distruzioni molteplici e continuative, che permangono ancora oggi. La stragrande maggioranza delle città precolombiane soccombette all’avanzata della conquista. Le antiche città dell'epoca coloniale, ricostruite nella prima epoca repubblicana, sono state sepolte dalla modernità. E la migrazione dalle campagne alla ricerca delle “luci della città” è inarrestabile.
Un altro punto cruciale risiede nello svuotamento delle campagne che esercita una pressione demografica sulle città. E questa valanga di persone che si allontanano dalla vita rurale aggrava i problemi sociali, tra i quali spicca sempre più una devastante frenesia individualizzante: quest’ultima è una cosa da tenere in considerazione: basti vedere come, in Gran Bretagna, dal gennaio 2018, è stato istituito il Ministero della Solitudine (BBC Mundo, Editorial, 2018) per occuparsi di milioni di persone che non sono economicamente povere, ma che nelle città vivono un disagio a causa dell’esacerbazione di queste tendenze individualizzanti ed egoistiche: una decisione adottata anche in Giappone dal febbraio 2021 (Miguel Trula, 2021).
Questa evoluzione risponde soprattutto alle pressioni create dall’accumulazione capitalista e dalla mercificazione urbana, tipiche nella logica delle economie dipendenti dalle logiche dell’accumulazione primaria-esportatrice. Queste città “periferiche” continuano a sperimentare diverse complicazioni, esistenti anche nelle città dei paesi centrali o industrializzati. Pertanto, tra le tante questioni molto preoccupanti, nelle città i volumi di immondizia e rifiuti sono diventati enormi, con un’impronta ecologica insostenibile.
Parallelamente, gli spazi pubblici – strade e piazze – sono subordinati alla logica del consumo frammentato e stratificato, segregato secondo le esigenze di accumulazione e mercificazione. Ai relativamente pochi quartieri “moderni” si contrappongono i giganteschi quartieri “miseria”, dove normalmente (soprav)vivono coloro che costruirono e mantengono i ridotti spazi di elevato benessere nelle città. La stessa violenza provocata con diverse forme di criminalità trova spiegazione in queste realtà di crescente barbarie.
Sembrerebbe addirittura pertinente parlare di un “estrattivismo urbano”, per usare le parole di Enrique Viale (Prologo, in Vásquez Duplat, 2021). In quest’area di mercificazione urbana sfrenata, di cui la gentrificazione non è l'unica manifestazione, appare il benessere legato al prezzo: vale a dire che “quanto più è caro, 'migliore' è il quartiere” , come sottolinea Viale. Questo “successo” si misura con indicatori legati al business immobiliare – ad esempio, attraverso i metri quadrati di edilizia che si concentrano nei quartieri più abbienti – e che non parlano della qualità della vita della popolazione in generale, ciò che consolida ancor più città ancora disequilibrate e disequilibranti.
.jpg) Questa realtà non può essere assunta come simbolo di progresso, anzi. Le città dell’America Latina e molte altre nel mondo, si potrebbe dire, sintetizzano la gravità di questi problemi, al punto da essere città “degradate, violente, malsane, privatizzate e antidemocratiche”, per dirla con le parole dello stesso Viale.
Questa realtà non può essere assunta come simbolo di progresso, anzi. Le città dell’America Latina e molte altre nel mondo, si potrebbe dire, sintetizzano la gravità di questi problemi, al punto da essere città “degradate, violente, malsane, privatizzate e antidemocratiche”, per dirla con le parole dello stesso Viale.
Nonostante gli enormi problemi strutturali, nelle città ci sono anche opzioni di trasformazione. Ci sono anche lotte storiche e azioni proprie di alternative radicali, alcune già in atto. Per valorizzare questi processi è urgente approfondire riflessioni e azioni che elevano gli elementi più trascendenti che ci permettano di costruire o ricostruire relazioni di maggiore armonia con la Natura.
La sfida è ripensare le città, ridisegnarle, riorganizzarle – soprattutto dal basso -, ristabilendo il loro equilibrio con il rurale (che va profondamente rivalutato e promosso), decolonizzando l’immaginario, favorendo anche la riduzione delle dimensioni delle città più grandi e la loro effettiva decentralizzazione, oltre a molte altre questioni. Da quanto sopra, ad esempio, vale la pena riflettere in che misura sia possibile porre fine alla netta separazione urbano-rurale e promuovere nuove forme di organizzazione sociale in cui l’idea stessa di migrazione dalle campagne alla città perde significato. Ed è tempo di raccogliere la sfida lanciata da Gustavo Duch, direttore della rivista Soberanía Alimentaria: ruralizzare le città, cioè trasferire nei centri urbani alcune caratteristiche che rendono le città più sane e accoglienti, sia per migliorare la qualità della vita, avere un'aria più pulita e anche abbassare le temperature, ampliando gli spazi verdi e piantando alberi nelle piazze e nelle strade, per migliorare la qualità della vita con livelli più alti e migliori di partecipazione cittadina e più tempo libero.
Questi temi, e altri appena delineati in questo testo, sono oggetto di riflessione in molte parti del mondo. Di fronte alla pressione dominante delle soluzioni tecnologiche – che non risolvono “il problema” –, si registra in tutto il pianeta e da parecchio tempo la costruzione di alternative. La questione si riflette in questioni politiche fondamentali, come chi pianifica, chi decide e chi esegue le politiche urbane. Esistono varie risposte a queste domande e anche possibilità di profonda trasformazione. Il tema è sempre politico.
Le autorità municipali hanno un’enorme responsabilità di fronte a tante complicazioni e sfide. Speriamo che chi ricopre funzioni pubbliche capisca che il lavoro non va fatto per i quartieri, cioè dall'alto, ma con i quartieri, provocando potenti effetti sinergici dal basso. Naturalmente i cittadini, organizzati in quartieri e comunità, in nessun caso possono aspettare a braccia conserte le risposte da parte delle amministrazioni. Anche se si dovrebbero esigere cambiamenti e interventi da parte delle istituzioni locali, ciò non è comunque sufficiente. In questo scenario, parafrasando e ampliando ciò che raccomandava il grande pensatore peruviano Aníbal Quijano quando si riferiva allo Stato, “è necessario agire dentro ai municipii e contemporaneamente contro i municipi, così come anche fuori da essi.
Senza pretendere di presentare un elenco dettagliato e ancor meno completo delle azioni che potrebbero essere promosse, ne evidenziamo alcune che ci sembrano rilevanti, tenendo presente la necessità di prospettare azioni immerse in strategie di transizione variegate:
-
Pianificare e riordinare le città, approfittando delle potenzialità esistenti, nonché superando le aberrazioni che non consentono l’utilizzo razionale delle risorse esistenti: per esempio, case e terreni svuotati a causa di carenze nella progettazione urbana o per effetto di pressioni speculative.
-
Superare la gestione immobiliare commercializzata e speculativa, nonché la gestione dello Stato fornitore, responsabile di molte dipendenze clientelari. Su questo punto individuiamo il potenziale che hanno le politiche fiscali nelle città, a partire da quelle conosciute come tasse sulla proprietà, che dovrebbero partire dal principio base per promuovere migliori livelli di equità: chi guadagna di più e ha di più, paga di più. Allo stesso modo, ci sono molte altre opzioni per fermare l’esistenza delle cosiddette “terre da ingrasso”, cioè quei terreni i cui proprietari lucrano sulle crescenti plusvalenze. E anche una tassazione ecologica non dovrebbe essere scartata.
-
Pensare a un’altra architettura per un’altra città richiede una comprensione di una vita differente, che inizia con il riutilizzo delle risorse disponibili, enfatizzando “l’intelligenza del semplice” per sostituire l’aggiornamento tecnico degli “edifici intelligenti”; si continua con la preservazione dell'esistente rispetto alle demolizioni non necessarie; l'utilizzo di materiali completamente riutilizzabili o compostabili;l'aumento della durabilità dei beni materiali, bandendo ogni obsolescenza programmata; l’abbandono dei materiali a base di carbonio e di combustibili fossili nell'edilizia, sostituendoli in una prospettiva di efficienza energetica. Un’architettura e una pianificazione urbana in chiave biocentrica richiedono, tra le tante cose, la compressione e la trasformazione della mobilità.
-
Promuovere, a partire da un’architettura per l’autonomia, l’attivazione, la coltivazione e il riconoscimento di territori educativi – spazi che si propongono di decolonizzare il pensiero e i corpi – come base fondamentale per trasformare le città, tenendo come orizzonte il Buen Vivir. E ciò, in linea con la messa in sintonia della vita con i cicli della Natura, implicherebbe una decelerazione dei ritmi urbani, stabilendo - ad esempio - un limite di velocità di 30 chilometri orari per tutti i veicoli nelle città.
per l’autonomia, l’attivazione, la coltivazione e il riconoscimento di territori educativi – spazi che si propongono di decolonizzare il pensiero e i corpi – come base fondamentale per trasformare le città, tenendo come orizzonte il Buen Vivir. E ciò, in linea con la messa in sintonia della vita con i cicli della Natura, implicherebbe una decelerazione dei ritmi urbani, stabilendo - ad esempio - un limite di velocità di 30 chilometri orari per tutti i veicoli nelle città.
-
Recuperare gli spazi urbani per i cittadini superando la dittatura dell'automobile. L'automobile appartiene a una classe di prodotti che non possiamo modificare a nostro piacimento: il suo utilizzo richiede determinate infrastrutture, si sostiene con modelli di dominio elitario, incluso patriarcale, e con l'esclusione delle masse, a tal punto che la stessa massificazione delle automobili ne distrugge i vantaggi. Urge quindi favorire in maniera massiccia il trasporto pubblico – soprattutto gli autobus, ampliandoli sempre più e privilegiando gli spazi per biciclette e pedoni – in linea con i profondi cambiamenti nella pianificazione e gestione del suolo.
-
Ottenere il controllo comunitario sulle tecnologie è un altro punto necessario da considerare. I sistemi di comunicazione comunitaria potrebbero, ad esempio, essere incoraggiati espandendo l’accesso alle reti sociali in forma gratuita e sicura. Non dimentichiamo che la tecnica e la tecnologia non sono neutre, che ogni tecnica si riferisce a una “forma sociale”, che implica un modo di relazionarci e di costruire noi stessi: basta guardare la società che “produce” l’automobile e il tipo di energia che richiede.
-
Impegnarsi in azioni per assicurare l’utilizzo delle energie comunitarie non può essere qualcosa che manca, in una transizione profonda. Esistono già numerosi esempi di come si possa generare elettricità in piccole unità, anche nelle abitazioni, oltre ad altri modi per sfruttare l’energia solare ed eolica, senza causare nuovi danni a causa dell’estrattivismo incontrollato causate da molte delle considerate “energie pulite”. E, a tal proposito, una transizione energetica non deve solo sostituire i combustibili fossili con altre fonti energetiche: è fondamentale approfondire il tema del consumo, della generazione e della distribuzione, nonché chi e come controlla tutti questi processi. La questione energetica non è solo tecnica ed economica, come propone la transizione energetica aziendale: è eminentemente politica.
-
Incoraggiare il diritto al tempo libero creativo prima del diritto al lavoro è una delle questioni più trasformative (Acosta, in Acosta et al., 2021). Ciò richiede il superamento dei lavori alienanti, come lo sfruttamento delle donne in casa, così come i lunghissimi percorsi di trasporto per accedere ai luoghi di lavoro. Qui emerge, insomma, la necessità di una revisione complessiva del tempo dedicato al lavoro. Una questione sollevata dalla riorganizzazione della vita stessa.
-
Rivalutare le risposte per garantire – almeno in parte – la sovranità alimentare delle città, ad esempio promuovendo orti urbani e progetti alimentari basati sulla produzione locale. Qui c’è molto spazio per le politiche alimentari a livello municipale, soprattutto a livello di consumo, ma anche di produzione: le città richiedono sempre più spazi verdi, pieni di vita e biodiversità - ad esempio con orti urbani nei parchi e nelle unità educative. –, come parte di un processo di educazione ecologica e anche di recupero della maggior quantità possibile degli equilibri perduti dall’espansione delle città, come la tombatura dei letti dei fiumi o dei torrenti.
-
Incoraggiare i cambiamenti nei modelli di consumo deve essere visto come un atto politico e perfino come un atto di ribellione quotidiana. A questo punto bisognerebbe promuovere la realizzazione di spazi di consumo condiviso, visti non solo come un’azione disperata di fronte alla povertà estrema, ma come una solidarietà praticata: le pentole comunitarie o lo scambio di strumenti domestici nell'ambito del quartiere, per citare un paio di esempi da una lunga lista di opzioni alternative, rappresentano un'opportunità per consolidare legami di vicinato e di fiducia, in linea con altre forme di risonanza e reciprocità.
-
Sostenere, ricostruire e promuovere il tessuto commerciale, produttivo, artigianale e di servizi nel territorio del quartiere è fondamentale. Ciò si realizzerà soprattutto attraverso le piccole imprese, ma ancor più con iniziative comunitarie, cooperative e associative. Per raggiungere questo obiettivo, i quartieri dovranno essere liberati dai grandi centri commerciali, che non solo causano la scomparsa di centinaia di imprese più piccole, ma portano anche allo svuotamento dello spazio pubblico circostante, creando le condizioni per il fiorire di ogni tipo di delinquenza.
-
Valorizzare la capacità di costruire in maniera partecipativa altre forme di economia nelle città, con gestione propria e autonoma, come quelle che potrebbero essere realizzate attraverso l’uso delle monete comunitarie, delle reti di scambio, delle officine di riparazione, per citare solo un paio di esempi di una lista molto lunga di esperienze esistenti.
-
Promuovere reti di sostegno per gestire diritti, tutele e difese contro abusi e violazioni, in particolare per donne, ragazze, ragazzi, giovani e migranti, nonché per gli anziani abbandonati; e anche per gli animali domestici abbandonati.
-
Assumere i quartieri e le comunità come motori di trasformazione globale, che siano spazi emancipati e emancipatori pieni di solidarietà di vicinato, vita intensa, autosufficienza e democrazia. Sono necessarie azioni di artisti urbani che plasmino allegria – da non confondere con la happycrazia neoliberista (Cabanas, 2019) – e molta ribellione nelle strade, nelle piazze e sugli stessi muri delle città, per corrodere quelle basi conservatrici che caratterizzano le società coloniali patriarcali, neoliberiste.
-
Rafforzare la “libera associazione” sulla base di una democrazia comunitaria radicale e orizzontale. Quello sarà il motore che garantirà la libertà individuale che dovrà essere raggiunta come comunità. Questo è un compito che richiede chiarezza, creatività e perseveranza: la (ri)costruzione dei tessuti comunitari: in realtà, ciò che serve è potenziare l’ingegno sociale per, a sua volta, promuovere democraticamente “la società autonoma”. È necessario sfruttare l’esistenza nelle città di “gironi di comunità”, che provengono in parte dalle migrazioni dai mondi rurali (indigeni e afro) e da altre molteplici forme di organizzazione della vita.
-
Ripristinare i livelli di sicurezza nelle città è una delle questioni più urgenti e complesse. La sfida è come raggiungere livelli più elevati di occupazione comunitaria di strade e piazze. Ciò sarà possibile rafforzando nei quartieri le attività produttive e commerciali, l'educazione, la salute, il tempo libero, lo sport, l'arte: insomma, attraverso tutte le espressioni di una vita comunitaria democratica. Solo con relazioni forti e che rispettino le differenze si potrà ottenere questo recupero degli spazi pubblici, non con più polizia e repressione.
 Urge, insomma, promuovere la ricomposizione della quotidianità rivalutando la convivenza in comunità, la costruzione e la difesa dei beni comuni, il consolidamento di storie e saperi comuni, l'autogestione della produzione e della distribuzione, le attività finalizzate alla riproduzione della vita, deprivatizzazione e recupero comunitario (non statalizzato) di beni e spazi pubblici. In questo sforzo, acquisisce importanza la stessa ricerca di alternative che aiutino a superare quell'opzione perversa che emerge quando si assume che le necessità sono infinite, che l'accumulazione materiale deve essere permanente, che avere di più ci rende più felici... errori così diffusi e tipici della civiltà che oggi ci domina.
Urge, insomma, promuovere la ricomposizione della quotidianità rivalutando la convivenza in comunità, la costruzione e la difesa dei beni comuni, il consolidamento di storie e saperi comuni, l'autogestione della produzione e della distribuzione, le attività finalizzate alla riproduzione della vita, deprivatizzazione e recupero comunitario (non statalizzato) di beni e spazi pubblici. In questo sforzo, acquisisce importanza la stessa ricerca di alternative che aiutino a superare quell'opzione perversa che emerge quando si assume che le necessità sono infinite, che l'accumulazione materiale deve essere permanente, che avere di più ci rende più felici... errori così diffusi e tipici della civiltà che oggi ci domina.
Queste visioni chiudono gli spazi a proposte omogeneizzanti, caudilliste, ortodosse. Insomma, dai quartieri e dalle città si devono costruire nuovi significati della vita che sostituiscano la fede nel profitto infinito, senza dimenticare che gli individui e le comunità sono chiamati ad assumere la rappresentanza dei Diritti della Natura nelle proprie città e quartieri.
È giunto il momento, quindi, di rafforzare in modo decisivo le lotte e le risposte della comunità. Se prestiamo un po’ di attenzione e – in senso figurato – stiamo in silenzio, possiamo sentire il futuro respirare. Le proposte alternative ci sono. La costruzione del pluriverso [12] è in corso e le città, nonostante le enormi difficoltà che contengono, appaiono come spazi potenti per l'emancipazione.[13]
Per raddoppiare la lotta per tutti i diritti
Chiudiamo a questo punto queste riflessioni con un paio di conclusioni: le Costituzioni hanno sempre risposto a problemi posti in diversi momenti storici. In questo contesto sono sempre stati spazi di disputa politica. Nella nostra America, l’ago della bilancia pende quasi sempre verso costituzioni elitarie, con le quali i gruppi di potere consolidano i propri privilegi, cercando di congelare i modelli di dominio o di accumulazione: è il caso del Cile. Senza sminuire questa dura realtà e riconoscendo che poche costituzioni hanno avuto effetti di profonda trasformazione, dobbiamo accettare i contributi accumulati nel tempo.
Da una prospettiva storica, nel XIX secolo furono sviluppate le costituzioni per creare repubbliche, superando così la zavorra coloniale. Queste costituzioni si orientarono gradualmente verso il riconoscimento dei diritti civili e politici, man mano che maturarono alcune strutture repubblicane. Poi, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, furono elaborate delle costituzioni che cercarono di affrontare in modo piuttosto timido la disuguaglianza, e la risposta fu quella di riconoscere i diritti economici, sociali e culturali; successivamente sono entrati in scena i diritti collettivi. Attualmente i diritti ambientali, derivati dai Diritti Umani, sono sempre più rafforzati e sta progressivamente emergendo la possibilità di assumere costituzionalmente la Natura come soggetto di diritti. Quindi, se il XX secolo è stato il secolo dei Diritti Umani, il XXI secolo sarà il secolo dei Diritti della Natura.
Pertanto, riconoscere la Natura come soggetto di diritti, così come tutti quei diritti improntati ai principi sociali e solidali, inclusivi e paritari, plurinazionali ed egualitari, ma soprattutto democratici, che si sono plasmati nella Convenzione Costituzionale cilena, che ha concluso i il suo percorso il 4 luglio 2022, costituisce un riferimento storico indiscutibile nonostante la circostanziata sconfitta alle urne e la battuta d’arresto che ne è seguita.
diritti, così come tutti quei diritti improntati ai principi sociali e solidali, inclusivi e paritari, plurinazionali ed egualitari, ma soprattutto democratici, che si sono plasmati nella Convenzione Costituzionale cilena, che ha concluso i il suo percorso il 4 luglio 2022, costituisce un riferimento storico indiscutibile nonostante la circostanziata sconfitta alle urne e la battuta d’arresto che ne è seguita.
Un altro mondo sarà possibile se – lungo il percorso – immaginiamo e costruiamo società (e città) partendo da principi totalmente opposti alla civiltà attuale, causa di tanti e crescenti squilibri, frustrazioni e violenze. Abbiamo bisogno di creare relazioni piuttosto che generare frammentazione; reciprocità invece di competizione sfrenata; solidarietà e corrispondenza invece che individualismo egoistico; cooperazione reciproca invece di concorrenza accanita; diritto a una vita dignitosa invece del diritto assoluto alla proprietà privata o al profitto infinito. L’avidità, che governa il capitalismo, deve essere sostituita dalla ricerca di una vita in armonia.
Decelerazione, decentramento e deconcentrazione delle città devono fermare il parossismo del consumismo e del produttivismo sfrenato. Tutto questo sforzo deve provenire dalla comunità, dai quartieri, ovverosia da territori specifici. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo disarmare – democraticamente – le strutture gerarchiche patriarcali, razziste, depauperanti, distruttive, concentratrici, poliziesche e, soprattutto, autoritarie. E soprattutto dobbiamo ristabilire quante più relazioni equilibrate possibili con la Natura nelle città e dalle città.
Ci troviamo di fronte a complessità che sono inspiegabili da una prospettiva monocausale e che non potranno essere risolte attraverso semplici azioni congiunturali. Abbiamo bisogno di risposte molteplici, diverse, piccole e grandi, anche globali (se possibile...), ma sempre radicali, cioè che cerchino di risolvere i problemi alla radice. Senza escludere le potenzialità di cambiamento delle possibili azioni di governo (soprattutto quelle municipali), dobbiamo sempre tenere presente che il controllo su corpi e territori è nel mirino del potere: quei corpi e territori sono e saranno i campi di battaglia. La lotta, quindi, sarà dal basso, moltiplicando ribellioni, resistenze e disobbedienza cittadina, nonché progetti alternativi in tutti gli ambiti della vita, sia di fronte ai grandi che ai piccoli e quotidiani abusi di potere, che finiscono per costruire e consolidare egemonie e strutture gerarchiche.
Per chiudere queste righe in questo libro sul costituzionalismo urbano, accettiamo che, in sintesi, dobbiamo costruire città veramente umane e sempre più sostenibili, basate soprattutto su processi comunitari di emancipazione, senza chiedere il permesso.
(3. Fine)
* Alberto Acosta: Nonno, economista ecuadoriano, professore universitario, Ministro dell'Energia e delle Miniere (2007), Presidente dell'Assemblea Costituente (2007-2008), candidato alla presidenza della Repubblica dell'Ecuador (2012-2013), autore di diversi libri, compagno nelle lotte dei movimenti sociali.
** Traduzione di Giorgio Tinelli per Ecor.Network
*** Articolo apparso su Rebelión il 29/09/2023, "Derechos de la Naturaleza, una lectura más urbana a partir de la nonata Constitución chilena" e tratto dal testo:
Constitucionalismo urbano: La ciudad en los procesos constituyentes en América Latina
a cura di: Fernando Carrión, Emilia Silva, Alfredo Rodríguez, Ana Sugranyes,
FLACSO Ecuador, settembre 2023 – 487 pp.
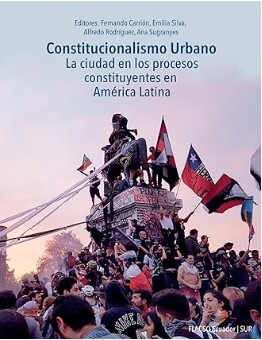
Immagini:
Per questo articolo, per declinare il concetto di estrattivismo urbano, abbiamo scelto le immagini di Blu.
c Berlín. Blu. Street art, by Marta Nimeva Nimeviene.
Licenza CC BY 2.0.
The City That Ate Greenery mural, Belgrade Serbia,2009, by jay galvin.
Licenza CC BY 2.0.
Nov2011 (438), by Lord Jim.
Licenza CC BY 2.0.
Oct. 2013 1055, by Lord Jim.
Licenza CC BY 2.0.
Blu, Street Art at Tate Modern, by Loz Flowers.
Licenza CC BY-SA 2.0.
wall art, by veritatem.
Licenza CC BY 2.0.
Note:
[10] Un cambiamento nella visione che abbiamo della spazzatura sarà enormemente utile. Si veda a questo proposito Solíz Torres (2021).
[11] L’elenco delle persone che affrontano il tema della città – nell’ampio spettro della ricerca del progresso e dello sviluppo, con in gioco la crescita economica – è enorme. Ricordiamo però un paio di riferimenti che lo fanno in maniera critica e che vale la pena evidenziare: Saskia Sassen, che ha pubblicato un importante libro sull'argomento: The Global City ; Fernando Carrión Mena, architetto ecuadoriano, uno dei maggiori esperti in materia, la cui produzione di ricerca è meritevole di riconoscimento; Basta vedere una selezione dei suoi contributi su https://works.bepress.com/fernando_carrion/
[12] Cfr. Kothari et al., Pluriverse (2019), opera di cui esistono edizioni in Ecuador, Spagna, Perù, Bolivia, Colombia, Brasile, Italia, Francia, Germania. Il libro, con 110 articoli scritti da 120 persone provenienti da tutti i continenti, è disponibile in inglese. su https://radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse/
[13] L’autore di queste righe si preoccupa da tempo di questo tema. Vedi Acosta (2019b).
Bibliografia
- Acosta, A. (2013). El Buen Vivir Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. ICARIA.
- Acosta, A. (2017, dic. 12). ¡Sustentabilidad, cuantas tonterías se dicen en tu nombre! La Línea de Fuego [Revista digital]. https://lalineadefuego.info/sustentabilidad-cuantas-tonterias-se-dicen-en-tu-nombre-por-alberto-acosta/
- Acosta, A. (2019). Construcción constituyente de los Derechos de la Naturaleza – Repasando una historia con mucho futuro. En L. Estupiñán, C. Storini, R. Martínez & F. A. de Carvalho Dantas, La Naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático (pp. 155-206). Universidad Libre, Bogotá / Universidad Andina, Quito. https://uninomadasur.net/?p=2159
- Acosta, A. (2019). La gran transformación desde los barrios – La ciudad, un espacio de emancipación. Rebelión. https://rebelion.org/la-ciudad-un-espacio-de-emancipacion/
- Acosta, A. (2021). Ocio y trabajo, en clave de Buen Vivir. Reflexiones para construir otro futuro. En A. Acosta, A. Pascual García & R. Munck (Eds.), Posdesarrollo. Contexto, contradicciones y futuros (pp. 411-440). Abya-Yala.
- Acosta, A. (2022, marzo 10). Sin derechos de la naturaleza la libertad es una ilusión. El Mostrador. https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/03/10/sin-derechos-de-la-naturaleza-la-libertad-es-una-ilusion/
- Acosta, A. (2022, marzo 17). Chile reconoce los derechos de la Naturaleza. Latinoamérica 21. https://latinoamerica21.com/es/chile-reconoce-los-derechos-de-la-naturaleza/#:~:text=Despu%C3%A9s%20de%20una%20larga%20disputa,y%20forman%20un%20conjunto%20inseparable
- Acosta, A. (2022, abril 26). El agua, un bien común inapropiable – Avanza la Convención Constitucional en Chile. Observatorio Plurinacional de Aguas. (OPLAS). https://oplas.org/sitio/2022/04/26/alberto-acosta-el-agua-bien-comun-inapropiable-un-logro-constitucional/
- Acosta, A. & Brand, U. (2017). Salidas del laberinto capitalista – Decrecimiento y Post-extractivismo, ICARIA. https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Libro-Salidas-del-Laberinto.pdf
- Acosta, A. & Cajas-Guijarro, J. (2020). Buscando fundamentos biocéntricos para una post-economía – Naturaleza, economía y subversión epistémica para la transición. En G. Günther & Meireles, M.(Coords.), Voces Latinoamericanas – Mercantilización de la Naturaleza y Resistencia Social (pp. 23-64). Universidad Autónoma Metropolitana, México.
- Acosta, A., García-Macías & Munck, R. (Eds.). (2021). Posdesarrollo. Contexto, contradicciones y futuros. Abya-Yala. http://www.obela.org/recomendaciones/posdesarrollo-contexto-contradicciones-futuros
- Ávila Santamaría, R. (2022). El constitucionalismo transformador y la Constitución en Chile. Plan V – Hacemos Periodismo. Historias. https://www.planv.com.ec/historias/analisis/el-constitucionalismo-transformador-y-la-constitucion-chile
- Bacilago, J. (Entrevista17.10.2022). “Chile seguirá viviendo una especie de reforma constitucional permanente”. Disponible https://rebelion.org/sergio-grez-chile-seguira-viviendo-una-especie-de-reforma-constitucional-permanente/
- BBC Mundo, Redacción. (2018, enero 18). La soledad, un mal contemporáneo mundial que en Reino Unido ahora es asunto de Estado. BBC News – Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-42723066
- Bosselmann, K. (2021). Ohne Rechte der Natur bleibt Freiheit Illusion. Netzwerk Rechte der Natur https://www.rechte-der-natur.de/de/aktuelles-details/119.html
- Cabanas, E. (2919). Happycracia: Detrás de esta ideología de la felicidad lo que hay es neoliberalismo puro. [Entrevista, 28 de abril del 2019]. Tiempo argentino. https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/happycracia-detras-de-esta-ideologia-de-la-felicidad-lo-que-hay-es-neoliberalismo-puro/
- Constitución Política de la República de Chile, 2022. Propuesta. https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf
- Costa Cordella, E. (2021). Por una Constitución ecológica – Replanteando la relación entre sociedad y Naturaleza. Catalonia.
- Gudynas, E. (2014). Derechos de la Naturaleza: ética biocéntrica y políticas ambientales. Programa Democracia y Transformación Global, Red Peruana por una Globalización con Equidad, CooperAcción, Centro Latino Americano de Ecología, Lima. http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasDerechosNaturalezaLima14r.pdf
- Hervé, D. (2021). Hacia una Constitución Ecológica: Herramientas comparadas para la consagración constitucional de la protección del medio ambiente. FLACSO Chile. https://derecho.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2021/10/3-Hacia-una-Constitucion-Ecologica.pdf
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group II). (2022), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Sixth Assessment Report. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
- Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., Demaria, F. & Acosta, A. (Eds.). (2019). Pluriverse – A Post-Development Dictionary. Tulika Books, India. https://radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse/
- Latour, B. (2007). Nunca fuimos modernos – Ensayo de antropología simétrica. Siglo XXI Editores.
- Lefebvre. H. (1969). El derecho a la ciudad. Ediciones Península. https://monoskop.org/images/3/3c/Lefebvre_Henri_El_derecho_a_la_ciudad.pdf
- Leff, E. (2021). Ecología política, derechos existenciales y diálogo de saberes: horizontes de otros mundos posibles. En P. García Macías, R. Munck, A. Acosta (Coords.), Pensando y actuando fuera de la caja, en clave de post-desarrollo. Contexto, contradicciones y futuros. Co-edición Editorial Glasnevine (Dublín) y Abya Yala (Quito).
- Miguel Trula, E. (2021, feb. 23). Japón ya ha creado un Ministerio de la Soledad, la otra pandemia que nos deja el siglo XXI. Magnet. https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/japon-ha-creado-ministerio-soledad-otra-pandemia-que-nos-deja-siglo-xxi
- ONU, Programa para el Medio Ambiente (2022). Decisión histórica: la ONU declara que el medio ambiente saludable es un derecho humano. https://bit.ly/3M59ebi
- Rodríguez Ibáñez, M. (2018, julio 19). Resignificando la ciudad colonial y extractivista”. Los Muros. https://losmuros.org/194/mario-rodriguez-resignificando-la-ciudad-colonial-y-extractivista/
- Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, and Tokyo. Princeton University Press.
- Solíz Torres, M. F. (2021). La basura como Naturaleza: La basura con derechos. Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/8408
- Stutzin, G. (1984). Un imperativo ecológico: reconocer los Derechos de la Naturaleza. Ambiente y Desarrollo, 1(1), 97-104. https://opsur.org.ar/wp-content/uploads/2010/10/imperativo-ecologico.pdf
- Vásquez Duplat, A. M. (Comp.). (2021). Extractivismo urbano Debates para una construcción colectiva de las ciudades. Prólogo de E. Viale. Fundación Rosa Luxemburgo; Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI); Editorial El Colectivo. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/117217/CONICET_Digital_Nro.13d988da-d8e1-414d-8b05-17ef1326688c_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- VV.AA. (2021). Energías renovables, selvas vaciadas – Expansión de la energía eólica en China y la tala de Balsa en Ecuador . Acción Ecológica, Quito. https://www.accionecologica.org/energias-renovables-selvas-vaciadas-expansion-de-la-energia-eolica-en-china-y-la-tala-de-balsa-en-el-ecuador/