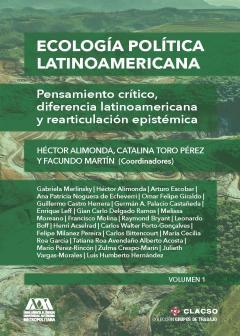L’America Latina/ Abya Yala è quella parte di mondo dove più si è data la tematizzazione - con una vasta produzione analitica e teorica - del saccheggio dei territori, delle popolazioni e della Natura.
Il concetto di estrattivismo ha qui la sua accezione originaria, così come quello di 'Buen Vivir'.
Ricco è il dibattito sulla critica allo sviluppo, che si articola con angolazioni plurali, integrando le elaborazioni accademiche a quelle prodotte dalle culture originarie e dalle pratiche quotidiane di resistenza popolare.
Anche l’Ecologia Politica non poteva che esprimere tale ricchezza, raccolta nei due volumi (liberamente accessibili) di "Ecología política latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica", editi nel 2017 dal Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, di cui proponiamo questa settimana la lettura.
Di seguito l’ introduzione dei curatori Catalina Toro Pérez e Facundo Martín.
Traduzione di Marina Zenobio per Ecor.Network.
In pochi anni l'Ecologia Politica in America Latina ha smesso di essere una proposta alquanto esotica di alcuni specialisti e ha acquisito, contemporaneamente all'affermazione della sua legittima presenza nel mondo accademico, una notevole rilevanza nelle richieste della sfera pubblica. Questo, evidentemente, accompagna la crescente natura conflittuale della questione ambientale nella regione e nel mondo.
Secondo autorevoli opinioni (come quella di Joan Martínez-Alier), l'Ecologia Politica latinoamericana è “un terreno di pensiero proprio con rilevanza internazionale”.
Si tratta di un campo di analisi, di critica e di enunciazione plurale, che si è costituito a partire dalla formazione di reti accademiche latinoamericane, situate in un rapporto di continuità con le tradizioni regionali di pensiero critico e con il complesso problema della costruzione dell'identità delle nostre società.
Questa Ecologia Politica è un tributo della storia latinoamericana e si propone di riscrivere la storia della regione, in diverse dimensioni, basandosi sulla ricostruzione delle relazioni tra società, culture e natura.
A partire dall'approccio delle relazioni società-natura da una prospettiva teorica interdisciplinare - costruita sull'intersezione tra storia ambientale e politica, la geografia critica, gli studi culturali e il pensiero ambientale - cerca di regolare i conti col passato, espandere il presente e progettare futuri al modello occidental-moderno.
Allo stesso tempo e fin dalla sua nascita, l'Ecologia Politica Latinoamericana è stata in una attiva relazione di permanente interscambio e feedback con i diversissimi movimenti e lotte protagoniste di conflitti su diverse scale e circostanze, raccogliendo le critiche ai modelli vigenti egemonici di sviluppo e delineando con essi altri futuri possibili.
In questo senso, i due volumi che presentiamo mantengono un dialogo sui dibattiti epistemologici dell'Ecologia Politica Latinoamericana e, allo stesso tempo, si intrecciano con le pratiche teoriche, politiche e territoriali che hanno caratterizzato la nostra regione. Questo marchio d'origine si basa sulla convinzione del legame, a volte teso e conflittuale ma anche creativo e produttivo, tra l'imperativo di affinare gli strumenti teorico-politici per assumere l'analisi critica e la costruzione costante di alternative di fronte al saccheggio, all'espropriazione e alla devastazione socio-ambientale.
produttivo, tra l'imperativo di affinare gli strumenti teorico-politici per assumere l'analisi critica e la costruzione costante di alternative di fronte al saccheggio, all'espropriazione e alla devastazione socio-ambientale.
In America Latina esiste tutto un complesso pensiero politico ambientale (Leff) che non solo contribuisce alla comprensione di queste dinamiche nella nostra regione, ma anche alla comprensione globale e storica di questi problemi (Alimonda, Castro H., Palacio); così come esiste un patrimonio di esperienze di lotta per la resistenza territoriale da parte dei movimenti sociali di fronte all'espropriazione e alla devastazione socio-ambientale (Porto-Gonçalves).
Una delle grandi sfide di questo recente lavoro, opera di ricercatori e attivisti latinoamericani, è quella di raccogliere e accompagnare le dinamiche dell'ecologismo popolare del continente, che rinnovano e molto spesso sfidano le proposte degli autori più citati negli ambienti accademici.
Crediamo che sia necessario riconoscere, rafforzare e legittimare questi saperi, i quadri teorico-politici e le pratiche contro-egemoniche che emergono dalle esperienze di lotta e resistenza nella nostra regione. E' questa la principale sfida accademica e politica che il Grupo de Trabajo Ecología Política desde América Latina / Abya Yala si è proposto di raccogliere.
D'altra parte riteniamo necessario superare la concezione e la denominazione di “risorse naturali” che, da un lato, implica un marcato antropocentrismo gerarchico e, dall'altro, rafforza l'ideologia funzionalista che il capitale ha su questi beni, concepiti come mere risorse.
Considerare questi beni come beni comuni significa che non possono essere privatizzati in alcun modo. Contestare questa nozione fin dal principio permette di aprire la strada all'idea di beni comuni, pone al centro della discussione il carattere relazionale comunitario e collettivo che storicamente e geograficamente i popoli hanno stabilito con i beni comuni, con le altre fonti e mezzi di esistenza per garantire la riproduzione della vita.
Un'importante sfida teorico-politica e pratica del Gruppo di Lavoro consiste nel rafforzare un dialogo costruttivo di saperi tra l'accademia e i movimenti sociali, dato che in America Latina e nei Caraibi questi movimenti, soprattutto quelli di base territoriale contadina e indigena, stanno dando importanti contributi alla comprensione di queste dinamiche e all'azione organizzata di resistenza attiva.
Le linee guida stabilite dal patto contadino-indigeno dietro l'ascesa del governo di Evo Morales in Bolivia, le rivendicazioni della Conaie in Ecuador, i postulati degli zapatisti in Messico o del movimento indigeno del Cauca, per citare solo alcuni esempi, costituiscono un insieme di contributi politici ed epistemici di questi movimenti sociali riconosciuti a livello mondiale (Santos, Alier), ma non sempre sufficientemente valorizzati dall'accademia.
Questo gruppo è impegnato in un vero e fruttuoso dialogo di saperi all'interno dell'Ecologia Politica e il suo nome non è casuale, Ecologia Politica dell'America Latina / Abya Yala, in quanto si pone sul versante critico, sia del capitalismo che dei nuovi/vecchi colonialismi.
Il lettore ha tra le mani il frutto delle riflessioni e dei dibattiti presentati in una serie di incontri che hanno avuto luogo tra il 2014 e il 2017.
Nel maggio 2014 Catalina Toro Pérez, coordinatrice del Gruppo di Lavoro, ha organizzato a Bogotà e a San Andrés, Colombia, il  seminario “Sviluppo, estrattivismo e conflitto in America Latina e nei Caraibi: uno sguardo dal punto di vista dell'Ecologia Politica”.
seminario “Sviluppo, estrattivismo e conflitto in America Latina e nei Caraibi: uno sguardo dal punto di vista dell'Ecologia Politica”.
L'evento ha visto la partecipazione di diversi ospiti internazionali, nazionali e locali ed è stato co-organizzato con l'Università Nazionale della Colombia: Istituto di Studi Caraibici, Gruppo Stato e Società dei Caraibi, Sede Caribe; Gruppo Diritto e Politica Ambietale, UNIJUS – Facoltà di diritto, Scienze Politiche e Sociali, Sede Bogotà e l'Istituto di Studi Ambientali IDEA, Osservatorio del Caribe.
Nel novembre 2014, Héctor Alimonda, con il sostegno di molti colleghi e di diverse università pubbliche di Rio de Janeiro, ha organizzato il “Seminario Internazionale Ecologia Politica in América Latina: Sfide pratiche e teoriche”.
In quell'occasione, Enrique Leff ha tenuto la Conferenza Magistrale in cui ha sviluppato alcuni degli aspetti affrontati nel suo capitolo. Carlos Walter Porto-Gonçalves, Henri Acselrad, Gian Carlo Delgado Ramos, Gabriela Merlinsky, Mina Lorena Navarro, Melissa Moreano e Horacio Machado Aráoz hanno anche presentato versioni precedenti dei loro contributi.
Nel novembre 2015 ha avuto luogo a Medellín, Colombia, la VII Conferenza Latinoamericana e Caraibica di Scienze Sociali, organizzata da CLACSO. In questo contesto il gruppo di lavoro ha sviluppato una serie di mostre e tavole rotonde con la partecipazione di Arturo Escobar, Guillermo Castro H., Ana Patricia Noguera de Echeverri, Carlos Walter Porto-Gonçalves, Héctor Alimonda, Gabriela Merlinsky, Catalina Toro Pérez, Milson Betancourt e Elisabeth Bravo.
Questo primo volume. intitolato “Ecologia Politica Latinoamericana. Pensiero Critico, Differenza Latinoamericana e Riarticolazione Epistemica”, contiene 16 capitoli organizzati in tre parti.
La prima parte, “Pensiero Critico e Identità geo-storiche”, affronta da diverse traiettorie e prospettive i modi di pensare e di essere in relazione con la storia e le identità latinoamericane. Come apertura presentiamo il lavoro di Héctor Alimonda che ci offre uno dei suoi ultimi sforzi intellettuali per riflettere sulla nozione di "avanguardia radicata" in riferimento al campo teorico e politico dell'Ecologia Politica Latinoamericana.
La rilevanza di questo campo rientra in un quadro plurale ma con caratteristiche proprie e vincolate alla tradizione del pensiero critico latinoamericano.
A continuazione, in un dialogo diretto con Héctor Alimonda, Arturo Escobar discute sulla vitalità del pensiero critico latinoamericano (PCL) e la sfida che rappresenta per la struttura epistemica della modernità. Sostiene che qualsiasi esercizio per fare un bilancio del PCL deve - per forza di cose - includere le categorie, i saperi e le conoscenze delle comunità e delle loro organizzazioni come una delle sue espressioni più potenti.
organizzazioni come una delle sue espressioni più potenti.
Nel terzo capitolo, Ana Patricia Noguera de Echeverry e Omar Felipe Giraldo si domandano: “perché poeti in tempi di estrattivismo ambientale?”
E ci offrono come risposta un lucido ed estetico invito a incorporare la poetica come parte del "pensiero ambientale del sud". Ci chiedono una “frenata a secco” che si opponga in modo contundente all'inclinazione alla devastazione calcolatrice, in cambio di una visione poetica del mondo.
Nel quarto capitolo, Guillermo Castro H. riflette sulle temporalità simultanee in Nuestra America. In effetti egli propone di capire la crisi ambientale in America Latina dal suo interno e allo stesso tempo di capirla nella sua relazione con la crisi globale. Sostiene che la principale sfida che comporta la comprensione della crisi è radicata nel modo in cui “tutti i tempi del processo storico” operano allo stesso tempo.
Per chiudere la prima parte, il quinto capitolo a cura di Germán Palacio C. mette in discussione, dal punto di vista della storia ambientale, la consolidata ma - a suo parere - obsoleta divisione Latino/Anglosassone. Ci invita quindi a prendere atto del carattere poroso e interconnesso della nostra storia ambientale con un'enfasi sulle relazioni transnazionali.
La seconda parte di “Repensar el mundo (de)sde la Ecología Política” si apre con il contributo illuminante ed erudito di Enrique Leff. L'autore traccia una genealogia dettagliata e ben argomentata dell'Ecologia Politica Latinoamericana in un chiaro dialogo in contrappunto con la versione anglofona, Political Ecology.
Cerca poi di problematizzare e radicalizzare le linee di indagine fondanti e costitutive del campo dell'ecologia politica, aprendo un dialogo contestualizzato su alcuni dei principi, idee e proposte fondamentali. Si conclude con un questionario al nucleo epistemico-pragmatico di questa corrente e, contemporaneamente, ci stimola a una riflessione più cosmopolita e critica per affrontare i poteri egemonici che oggi conducono il mondo verso il suo degrado.
Gian Carlo Delgado Ramos analizza, a continuazione, l'emergere di prospettive socio-ecologiche che cercano di superare il dualismo e il funzionalismo delle relazioni società-natura.
Sottolinea che, in base della prospettiva del metabolismo sociale, la sfida cognitiva delle nuove prospettive ecologiche critiche sta nello sviluppo di approcci interdisciplinari che permettono di mettere in discussione le stesse domande che tradizionalmente sono servite a definire il problema e la sua portata.
Da parte loro Melissa Moreano, Francisco Molina e Raymond Bryant intendono contribuire a una migliore comprensione della dimensione politica della questione ambientale, analizzando i contributi dell'Ecologia Politica Latinoamericana (EPL) e dell'Ecologia Politica globale.
Identificano la decolonialità, la posizionalità e il territorio come tre “marcatori di identità” centrali della EPL che permettono di delineare ciò che la distingue dall'ecologia politica anglosassone.
In quarto luogo, il teologo e professore brasiliano Leonardo Boff ci offre un'analisi della sfida ecologica futura, in considerazione dell'enciclica papale Laudato Sí e della Carta della Terra della COP21 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) tenutasi a Parigi alla fine del 2015. Mettendo in discussione i presupposti su cui si fondano le convenzioni internazionali e i loro schemi di governance, l'autore recupera la profondità dei compiti per ricostruire un nuovo paradigma ecologico.
Nel quinto e ultimo capitolo di questa seconda parte, Henri Acselrad affronta la genesi e la configurazione delle lotte per la giustizia ambientale in Brasile. Attraverso una genealogia dettagliata, l'autore sostiene che le lotte per la giustizia ambientale in Brasile abbiano abbinato la difesa dei diritti ad ambienti culturalmente specifici, la protezione ambientale e la difesa dei diritti di accesso alle risorse ambientali, rivendicando allo stesso tempo i diritti delle generazioni future. Lo avrebbero fatto affrontando il trasferimento dei costi ambientali dello sviluppo sui più poveri.
È qui che si darebbe una chiara Ecologia Politica o, nelle parole dell'autore, una “unione strategica tra giustizia ambientale e protezione ambientale”.
protezione ambientale”.
La terza e ultima parte, “Crisi, resistenza e sfide geopolitiche”, inizia con un articolo di Carlos Walter Porto-Gonçalves sulla dimensione geopolitica della crisi brasiliana.
Nel suo contributo, l'autore discute le implicazioni di un nuovo quadro geopolitico per i gruppi/classi sociali in una condizione di subalternità, che spesso sono lasciati fuori dalle analisi geopolitiche. Questi di solito ignorano i processi subalterni o lo fanno dalla prospettiva della dominazione e del controllo di gruppi e classi nazionali e sovranazionali. In questo modo ci avverte sulle implicazioni di questo processo non solo per il Brasile ma per tutta l'America Latina, e dell'urgenza di ascoltare ciò che ci dicono i popoli in lotta per la vita, la dignità e il territorio.
A continuazione, in dialogo con il lavoro precedente, Felipe Milanez presenta una riflessione critica su due recenti politiche messe in atto in Brasile: il “Programa de Aceleracao do Crecimento” (Programma di accelerazione della crescita) e “Ponte para o Futuro” (Ponte per il futuro). Contrapponendo questa prospettiva estrattivista e governativa ai contributi degli intellettuali indigeni e dei sacerdoti candomblé, l'autore delinea possibili intersezioni tra le prospettive della decrescita e quelle delle lotte indigene, afro-brasiliane e contadine.
In terzo luogo, Carlos Bittencourt, presenta l'analisi di un disastro che ha portato al crollo della diga di sterili nella miniera Samarco, città di Mariana, stato di Mina Gerais, Brasile.
Utilizzando la teoria del rischio e concentrandosi sulle relazioni istituzionali tra la compagnia mineraria e lo Stato, l'autore mette al centro della sua critica i meccanismi antidemocratici di controllo e le decisione sull'installazione di progetti estrattivi.
Nel frattempo, María Cecilia Roa García, Tatiana Roa Avendaño e Alberto Acosta affrontano la questione della democratizzazione ambientale come elemento centrale nel processo di pace nel post-conflitto colombiano. Mettono in guardia sulle potenziali implicazioni di questo processo storico in termini di espansione della frontiera estrattiva e delle forme di violenza ad essa associate.
Seguono Mario Pérez-Rincón, Zulma Crespo-Marín e Julieth Vargas-Morales con un'analisi informata delle dinamiche economiche della specializzazione produttiva e dei conflitti ambientali nei paesi andini. Per dimostrare queste relazioni, il lavoro si sviluppa a partire dalle prospettive concettuali dello studio della conflittualità ambientale, sullo studio della dinamica economica in termini utilitaristici e lo studio del metabolismo sociale. Gli autori concludono che i crescenti conflitti ambientali sono manifestazioni chiare e concrete dell'intensificazione dell'uso del territorio dovuto alla specializzazione produttiva nel settore estrattivo primario.
Infine, questa terza e ultima parte si chiude con un articolo di Luis Humberto Hernández su un'esperienza sistematizzata dell'Assemblea Nazionale per la Pace in Colombia. Da una prospettiva critica, l'autore elabora una proposta di politica pubblica nel settore petrolifero colombiano.
(1. Continua)
Ecología política latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. VOL.1
Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez, Facundo Martín (a cura di)
CLACSO, 2017, pp. 444.
con scritti di: C. Toro Pérez. G. Merlinsky. H.Alimonda. A. Escobar. A. P. Noguera de Echeverri. O.F. Giraldo. G.Castro Herrera. G.Palacio Castañeda. E. Leff. G. C. Delgado Ramos. M. Moreano. F. Molina. R. Bryant. L. Boff. H. Acselrad. C. W. Porto Gonçalves. F. Milanez Pereira. C.Bittencourt. M.C. Roa García. T.Roa Avendaño. A. Acosta. M. Pérez-Rincón. Z. Crespo-Marín. J. Vargas-Morales. L. H. Hernández.
Download: