
Il potenziale ecologico della “nuova” Costituzione cilena
La non-nata Costituzione cilena si proponeva di affrontare il problema globale più importante con cui si suicida la Modernità: il collasso ecologico, che trova nella crisi ambientale una delle sue manifestazioni. In un’epoca di estinzione di massa di specie e di inarrestabile distruzione della diversità, che mette a rischio la vita sul pianeta, tale testo costituzionale era all’altezza della sfida ecologica posta. Non solo espandeva il diritto ambientale, con indispensabili restrizioni alla proprietà privata e il riconoscimento del diritto umano a un ambiente sano, ma si è anche impegnato a favore della Natura. Il suo passo più importante in questo campo fu il riconoscimento della Natura come soggetto di diritti [5], accompagnato da una visione integrale e da una vigorosa istituzionalità incorporata nel testo costituzionale. Di fatto, questo riconoscimento è stato molto più ampio di quello stabilito nella Costituzione dell’Ecuador del 2008, l’unica che ad oggi riconosce i Diritti della Natura (Acosta, 2022, 10 marzo).
Fin dall'inizio, nel nuovo testo costituzionale [6] si stabilì che il Cile avesse uno Stato ecologico (articolo 1.1), riconoscendo “il suo rapporto indissolubile con la Natura” (1.2). Furono proposti con decisione l'interdipendenza, l'inseparabilità e il rapporto armonico con la Natura (8). Nella politica internazionale, lo Stato si impegnava a promuovere il rispetto della Natura (14.2). Sì definì con chiarezza che «la natura è proprietaria dei diritti riconosciuti in questa Costituzione e ad essa applicabili» (18.3, 127). Pertanto, in quella Costituzione si fissava il pieno esercizio dei diritti come essenziale per “l'equilibrio della Natura” (18). Di conseguenza, si affermava che la Natura “ha diritto al rispetto e alla tutela della propria esistenza, alla rigenerazione, al mantenimento e al ripristino delle sue funzioni ed equilibri dinamici, che comprendono i cicli naturali, gli ecosistemi e la biodiversità” (103). Questi diritti risultavano così importanti che avrebbero potuto essere limitati solo da leggi destinate a proteggere l’ambiente e la Natura (106).
stabilì che il Cile avesse uno Stato ecologico (articolo 1.1), riconoscendo “il suo rapporto indissolubile con la Natura” (1.2). Furono proposti con decisione l'interdipendenza, l'inseparabilità e il rapporto armonico con la Natura (8). Nella politica internazionale, lo Stato si impegnava a promuovere il rispetto della Natura (14.2). Sì definì con chiarezza che «la natura è proprietaria dei diritti riconosciuti in questa Costituzione e ad essa applicabili» (18.3, 127). Pertanto, in quella Costituzione si fissava il pieno esercizio dei diritti come essenziale per “l'equilibrio della Natura” (18). Di conseguenza, si affermava che la Natura “ha diritto al rispetto e alla tutela della propria esistenza, alla rigenerazione, al mantenimento e al ripristino delle sue funzioni ed equilibri dinamici, che comprendono i cicli naturali, gli ecosistemi e la biodiversità” (103). Questi diritti risultavano così importanti che avrebbero potuto essere limitati solo da leggi destinate a proteggere l’ambiente e la Natura (106).
Lo Stato avrebbe dovuto promuovere e garantire l'educazione ambientale per assicurare la cura della Natura e formare così una coscienza ecologica (39). L’elenco dei punti cruciali è enorme: l'energia diversificata, rinnovabile e a basso impatto ambientale (59); la proprietà tutelata, ad eccezione di quei beni “che la Natura ha reso comuni a tutti gli uomini e di quelli che la Costituzione e la legge dichiarano non appropriabili” (78.1); i patrimoni naturali e culturali per le generazioni future (101); l'accesso “responsabile e universale alle montagne, alle rive dei fiumi, al mare, alle spiagge, ai laghi, alle lagune e alle zone umide” (107.1).
Un aspetto importante ricadeva sull'obbligo dello Stato e della società di proteggere e rispettare i Diritti della Natura (127.1). Per raggiungere questo obiettivo si proponeva l’accesso alla giustizia ambientale (108.8); la legittimazione attiva ampia (134.6) da parte dell'Ufficio del Difensore della Natura e di qualsiasi persona o gruppo (119.8). Un aspetto centrale ricadeva sui principi che si applicano alla Natura: progressività, precauzione, prevenzione, giustizia ambientale, solidarietà intergenerazionale, responsabilità e azione climatica giusta (128.1); così come la riparazione (128.2); la tutela della diversità, l'habitat delle specie selvatiche autoctone, alle condizioni di sopravvivenza e di non estinzione (130). Si consideravano gli animali in quanto esseri senzienti, come “soggetti di protezione speciale…e il diritto di vivere una vita libera da maltrattamenti” (131). Punti d'interesse da prendere in considerazione sono le aree protette destinate a preservare, ripristinare e conservare gli spazi naturali (132); la regolamentazione e il recupero dei rifiuti (133).
 Mettiamo in evidenza l’istituzionalizzazione dei “beni comuni naturali”. La logica in questa materia è che, come accade con altri soggetti di diritti, ciò che è comune esce dalla sfera della regolamentazione della proprietà (inappropriabili 134.4). Il progetto li definisce come elementi o componenti della Natura su cui lo Stato ha “uno speciale dovere di custodia” (134.1): il mare, i fondali marini, le spiagge, le acque, i ghiacciai e i loro ambienti (137), le zone umide, i campi geotermici, l'aria, l'atmosfera, l'alta montagna, le aree protette, le foreste native, il sottosuolo, il cielo notturno (135.1), le foreste native (136), la connettività idrica (136), il ciclo idrologico (140.1), gli ecosistemi marini e insulari, l'ecosistema antartico (139) e altri ancora citati dalla Costituzione e dalla legge (134.2).
Mettiamo in evidenza l’istituzionalizzazione dei “beni comuni naturali”. La logica in questa materia è che, come accade con altri soggetti di diritti, ciò che è comune esce dalla sfera della regolamentazione della proprietà (inappropriabili 134.4). Il progetto li definisce come elementi o componenti della Natura su cui lo Stato ha “uno speciale dovere di custodia” (134.1): il mare, i fondali marini, le spiagge, le acque, i ghiacciai e i loro ambienti (137), le zone umide, i campi geotermici, l'aria, l'atmosfera, l'alta montagna, le aree protette, le foreste native, il sottosuolo, il cielo notturno (135.1), le foreste native (136), la connettività idrica (136), il ciclo idrologico (140.1), gli ecosistemi marini e insulari, l'ecosistema antartico (139) e altri ancora citati dalla Costituzione e dalla legge (134.2).
Punto a parte. Si riconosceva che l’attività estrattiva mineraria potrebbe generare tensioni con la vigenza dei Diritti della Natura, per cui si introdusse il trattamento di quelle che sono considerate “risorse naturali”. Veniva riconosciuta allo Stato “la proprietà assoluta, esclusiva, inalienabile ed imprescrittibile di tutte le sostanze minerali…” (145); ma non avvallò la nazionalizzazione dell'attività mineraria, in particolare del rame, come pretendevano alcune organizzazioni. In ogni modo, si stabilirono alcune considerazioni e restrizioni particolari: non estrarre nei ghiacciai e nelle aree protette (146), l'obbligo- nell'attività estrattiva - di considerare la tutela dell'ambiente, (147.1) nonché gli impatti sinergici (147.2). Queste precauzioni sarebbero state un punto di partenza per avviare, espandere e approfondire i processi post-estrattivisti, i quali non sono assicurati solamente da una maggiore partecipazione e controllo da parte dello Stato.
In termini istituzionali, veniva riconosciuta la democrazia ambientale. Si creava l'Ente per la Difesa della Natura come organismo autonomo con personalità e risorse proprie (148). Era presente una regolamentazione per la pianificazione territoriale e la protezione degli ecosistemi (197, 202.e e 220.g). Veniva stabilito un finanziamento per la cura e la riparazione degli ecosistemi, attraverso tributi sulle attività che potevano danneggiare l’ambiente e i beni comuni naturali (184). L'esercizio della giurisdizione doveva garantire la tutela e la promozione dei Diritti Umani e dei Diritti della Natura (207.3), attraverso tribunali di istanza ambientale (331.1, 333).
Da evidenziare un altro passaggio di enorme importanza: la Convenzione Costituzionale, nonostante i suoi alti e bassi, approvava che l’acqua in tutti i suoi Stati è un bene comune non appropriabile e assumendo anche il diritto umano all’acqua. Questo passo mirava a smantellare la mercificazione del liquido vitale e il suo conseguente saccheggio, uno dei pilastri del modello neoliberista, una decisione che deve essere valorizzata in tutta la sua importanza. Il Cile è un esempio paradigmatico di gestione privatizzata dell’acqua. Nell’ancora attuale Costituzione di Pinochet, integrata dal Codice delle Acque, si era separata l’acqua dalla vita, non solo dalla proprietà della terra, e l'acqua venne mercificata, sottoponendola alla domanda e all’offerta. In particolare sono stati trascurati i diritti delle comunità vittime dell'esproprio dell'acqua nei loro territori. E c'è di più: il proprietario dei diritti sull'acqua non paga costi per la sua manutenzione, possesso o utilizzo e non è tenuto a proteggere i bacini né a compensare eventuali effetti negativi sulla quantità e qualità dell'acqua utilizzata, che potrebbero colpire altri utenti. Questa logica mercantilista arrivò ad aberrazioni estreme quando, ad esempio, nella valle di Copiapó, nel nord del Cile, furono negoziati più diritti d’uso rispetto all’acqua effettivamente disponibile nel bacino.
Lo stress idrico di massa sofferto dal paese sudamericano non è solo una conseguenza del cambiamento climatico. Il Cile, paese ricco di risorse idriche è, a causa della stessa mercificazione dell’acqua, nel mezzo di un processo di desertificazione con la quasi totalità dell’acqua privatizzata, una situazione che peggiora quando non è più disponibile acqua superficiale e si ricorre alle acque sotterranee. Va notato che i principali responsabili di questa situazione sono l’estrattivismo, sia esso minerario che agro-esportatore e, con un impatto crescente, anche l’espansione urbana incontrollata. Come risultato di questa realtà, ci sono più di un milione di persone nelle città di tutto il Cile senza accesso all’acqua potabile. Un numero simile di persone nel settore rurale non dispone ancora delle infrastrutture per approvvigionarsi stabilmente di questo elemento, il che equivale a quasi un 50% della popolazione di questo settore (sul tema si veda Acosta, 2022, 26 aprile).
sudamericano non è solo una conseguenza del cambiamento climatico. Il Cile, paese ricco di risorse idriche è, a causa della stessa mercificazione dell’acqua, nel mezzo di un processo di desertificazione con la quasi totalità dell’acqua privatizzata, una situazione che peggiora quando non è più disponibile acqua superficiale e si ricorre alle acque sotterranee. Va notato che i principali responsabili di questa situazione sono l’estrattivismo, sia esso minerario che agro-esportatore e, con un impatto crescente, anche l’espansione urbana incontrollata. Come risultato di questa realtà, ci sono più di un milione di persone nelle città di tutto il Cile senza accesso all’acqua potabile. Un numero simile di persone nel settore rurale non dispone ancora delle infrastrutture per approvvigionarsi stabilmente di questo elemento, il che equivale a quasi un 50% della popolazione di questo settore (sul tema si veda Acosta, 2022, 26 aprile).
Le sfide che la nuova Convenzione cilena si è assunta con la sua storica decisione di dichiarare la non appropriabilità dell’acqua sono state molteplici. La società cilena avrebbe dovuto presupporre concretamente che l’acqua è un diritto umano e che è una componente fondamentale della Natura, la stessa che ha diritti propri di esistere e di mantenere i propri cicli vitali.
Per concretizzare i Diritti della Natura è necessario che gli obiettivi di ogni società siano subordinati alle leggi dei sistemi naturali, senza dimenticare in nessun momento il rispetto della dignità della vita umana. Diamo per assunto che nella fallita Costituzione cilena si aprivano le porte al Buen Vivir (Acosta, 2013) (il küme mogen del popolo mapuche), un’opzione di vita che non solo permette di vedere il mondo attraverso altri prismi, ma che contribuisce anche a superare tante aberrazioni proprie della Modernità.
Tutti questi temi sono stati oggetto di diverse letture in Cile. Da un lato, ha prevalso l’ignoranza sul significato profondo di questa Costituzione fallita. Anche in alcuni settori si fece sentire il timore, spesso infondato, di perdere privilegi a causa della sua applicazione. Si fece persino largo un argomento che ostentava l'inutilità di tali diritti, riferendosi all'esperienza ecuadoriana, disconoscendo quanto sia difficile rispettare pienamente molti diritti, come accade ad esempio con i Diritti Umani. È stato persino detto furbescamente che i Diritti Umani sarebbero stati subordinati ai Diritti della Natura e che avrebbero danneggiato il suppostamente affermato modello di sviluppo cileno. Al di là di queste domande, possiamo trarre una serie di conclusioni dal potente e – perché no – meraviglioso armamentario di risoluzioni costituzionali brevemente passato in rassegna.
Prima di proseguire premettiamo: se comprendiamo cosa rappresentano realmente i Diritti della Natura, che vanno oltre l'ambito ristretto dell'ambito giuridico propriamente detto, stiamo aprendo la porta per propiziare una trasformazione di profonda portata copernicana; cioè, una trasformazione di civiltà.
La natura come soggetto di diritti, una svolta copernicana in divenire
I Diritti della Natura che non possono essere confusi con il diritto dell'essere umano a un ambiente sano, esigono cambiamenti profondi in tutti gli ambiti della vita. In questo contesto, la Natura stabilisce i limiti e la portata di ogni attività umana: solo accettando questa questione si può garantire la sostenibilità e la capacità di rinnovamento dei sistemi. Facciamo un ulteriore passo avanti: se si distrugge la Natura, si distrugge la base della vita stessa. Ciò richiede di evitare l’eliminazione della diversità e la sua sostituzione con  l’uniformità, la quale produce - solo per fare esempi - l'attività mega-mining, le monocolture o le coltivazioni transgeniche. Tra le cose da evitare c'è anche la distruzione causata dallo sviluppo urbanistico incontrollato e, ancor più, dal gigantismo urbano. Mettere nero su bianco questo cambiamento storico è una delle più grandi sfide dell’Umanità, se non si vuole mettere a rischio la sua esistenza sulla terra.
l’uniformità, la quale produce - solo per fare esempi - l'attività mega-mining, le monocolture o le coltivazioni transgeniche. Tra le cose da evitare c'è anche la distruzione causata dallo sviluppo urbanistico incontrollato e, ancor più, dal gigantismo urbano. Mettere nero su bianco questo cambiamento storico è una delle più grandi sfide dell’Umanità, se non si vuole mettere a rischio la sua esistenza sulla terra.
Pertanto, invece di considerare la Natura come uno stock “infinito” di materie prime e una discarica “permanente” di rifiuti, avremmo la necessità di approntare anche un’altra economia (Acosta & Cajas-Guijarro, 2020). Per raggiungere questo obiettivo è necessario assumere, come punto di partenza e come obiettivo, la sostenibilità e l’autosufficienza dei processi economico-naturali, intesi come sistemi composti da molteplici interazioni e logiche complesse che si retro-alimentano ciclicamente.
In questo senso, il feticcio della crescita economica infinita in un mondo finito deve cedere il passo per lasciare spazio a processi che combinino la decrescita economica, soprattutto nei paesi che attualmente agiscono come centri capitalisti, mentre nella periferia, nel liberarsi progressivamente dalla religione della crescita economica permanente, si deve andare verso il post-estrattivismo (Acosta & Brand, 2017). La crescita deve essere affrontata in modo responsabile nei paesi “sottosviluppati”. È quanto meno appropriato differenziare la crescita “buona” da quella “cattiva”, come propose Manfred Max-Neef nel 2001: crescita che, secondo l’economista cileno, si definisce con le corrispondenti storie naturali e sociali che la spiegano.[7] In ogni caso, la crescita non dovrebbe essere né il motore né il fine ultimo dell’economia.
Questa critica alla crescita economica non significa mantenere i livelli di opulenza di pochi segmenti della popolazione nel Nord e nel Sud del mondo.
Di certo, queste azioni non possono cadere nella trappola né dello “sviluppo sostenibile” né del “capitalismo verde” con la sua pratica brutale di mercificazione ambientale (esemplificato nel – per non dire altro – carente mercato del carbonio). Il compito non è far diventare “verde” il capitale, ma semmai superare il capitale. Allo stesso modo, non possiamo cadere nella fiducia cieca verso la scienza e la tecnologia, le quali dovrebbero essere riformulate per garantire il rispetto dei diritti esistenziali. Insomma, scienza e tecnologia – insieme a una nuova economia – devono essere subordinate al rispetto dell’armonia tra uomo e Natura. E in questo ordine di cose la sfera sociale non può essere emarginata, poiché la giustizia ecologica va necessariamente a braccetto con la giustizia sociale, e viceversa.
Abbiamo bisogno di un mondo che si ritrovi di nuovo intorno alla vita, con dialoghi genuini di conoscenza e rincontri tra esseri umani, come individui e comunità, e tutti con la Natura, comprendendo che siamo un tutto. Fino a quando questa svolta di civilizzazione non si verificherà, i tempi a venire saranno sempre più difficili. Se comprendiamo davvero che l’esigenza di cambiamento è presente, è tempo di riannodare il nodo gordiano della vita a partire dalle più diverse approssimazioni possibili, come chiedeva Bruno Latour (2007).
Incorporare la Natura come soggetto di diritti in una Costituzione o in una legge, essendo un atto formalmente antropocentrico, se vogliamo davvero che questi diritti esistenziali si sviluppino nella realtà concreta, implica essenzialmente l’obbligo di andare verso visioni e pratiche biocentriche. Inoltre, difendere la Natura o Pachamama, è difendere noi stessi, poiché siamo Natura, capendo sempre che colei che veramente ci dà il diritto di esistere è la Madre Terra. Ecco l'origine di tutti i diritti!
Nella pratica giuridica ciò significa che, a partire.jpg) dalla validità dei Diritti della Natura, si accetta la capacità che la Natura ha come titolare di diritti. Nella giurisprudenza il diritto alla rappresentanza è stato progressivamente ampliato: questa capacità è concessa anche alle persone giuridiche, che sono entità astratte, fittizie, immateriali. La natura, invece, essendo materiale, reale e tangibile, non può rimanere fuori da questa capacità giuridica. E se l’incapacità delle persone viene compensata dalla rappresentanza, lo stesso vale per la Natura.
dalla validità dei Diritti della Natura, si accetta la capacità che la Natura ha come titolare di diritti. Nella giurisprudenza il diritto alla rappresentanza è stato progressivamente ampliato: questa capacità è concessa anche alle persone giuridiche, che sono entità astratte, fittizie, immateriali. La natura, invece, essendo materiale, reale e tangibile, non può rimanere fuori da questa capacità giuridica. E se l’incapacità delle persone viene compensata dalla rappresentanza, lo stesso vale per la Natura.
In conclusione, non esiste più alcun diritto a sfruttare senza pietà la Madre Terra e ancor meno a distruggerla, ma solo un diritto ad un uso ecologicamente sostenibile. Le leggi umane e le azioni umane, quindi, devono essere in accordo con le leggi della Natura. La loro vigenza risponde alle condizioni materiali che ne consentono la cristallizzazione e non ad un mero riconoscimento formale nel campo giuridico. E la sua proiezione, quindi, deve superare quelle visioni che intendono i diritti come compartimenti stagni, perché la sua incidenza deve essere multipla, diversificata, transdisciplinare.
Quanto esposto sopra, ci invita a sintonizzarci con la Democrazia della Terra, che ha le radici nel rapporto armonioso con la Natura, con comunità basate sulla giustizia sociale, la democrazia decentralizzata e la sostenibilità ecologica. Comprendere questo punto richiede una svolta copernicana [8] in tutti gli aspetti della vita, sia nell'ambito giuridico, economico, sociale o politico, ma soprattutto culturale. I Diritti della Natura, insomma, ci permettono altre letture della dura realtà che stiamo attraversando, dandoci allo stesso tempo strumenti per cambiarla dalle sue radici (Acosta, 2022, 17 marzo).
In relazione a quest'ultimo punto, i Diritti della Natura propongono non solo il superamento del modello di sviluppo estrattivista, ma anche la scomparsa del concetto stesso di sviluppo. E allo stesso modo, nel mezzo dell’attuale collasso ecologico, è già tempo di comprendere la Natura come condizione fondamentale della nostra esistenza e, quindi, anche come base dei diritti collettivi e individuali di libertà. Proprio come la libertà individuale può essere esercitata solo nel quadro degli stessi diritti degli altri esseri umani, la libertà individuale e collettiva può essere esercitata solo nel quadro dei Diritti della Natura. Il professore tedesco Klaus Bosselmann (2021) conclude categoricamente: “senza i diritti della natura, la libertà è un’illusione”.
Con questo impegno si sintonizzava la Costituzione respinta il 4 settembre 2022.[9] Nonostante il trionfo del Rifiuto, la non-nata Costituzione cilena ha molta vitalità, poiché funge da piattaforma per raddoppiare le lotte a tutti i livelli.
(2. Continua)
* Alberto Acosta: Nonno, economista ecuadoriano, professore universitario, Ministro dell'Energia e delle Miniere (2007), Presidente dell'Assemblea Costituente (2007-2008), candidato alla presidenza della Repubblica dell'Ecuador (2012-2013), autore di diversi libri, compagno nelle lotte dei movimenti sociali.
** Traduzione di Giorgio Tinelli per Ecor.Network
*** Articolo apparso su Rebelión il 29/09/2023, "Derechos de la Naturaleza, una lectura más urbana a partir de la nonata Constitución chilena" e tratto dal testo
Constitucionalismo urbano: La ciudad en los procesos constituyentes en América Latina
a cura di: Fernando Carrión, Emilia Silva, Alfredo Rodríguez, Ana Sugranyes,
FLACSO Ecuador, settembre 2023 – 487 pp.
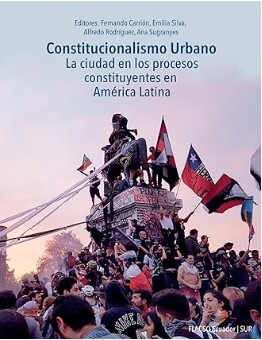
Note:
[5] L’elenco degli articoli e dei riferimenti sulla discussione dei Diritti della Natura nella Convenzione cilena è enorme. Come esempio pulsante segnaliamo il lavoro di Hervé (2021), e quello di Costa Cordella (2021).
[6] Per identificare i vari articoli rilevanti in termini di Diritti della Natura, ci rivolgiamo al testo dell’ex giudice costituzionale ecuadoriano Ramiro Ávila Santamaría, “Costituzionalismo trasformativo e Costituzione in Cile” (luglio 2022), in https:/ / www.planv.com.ec/historias/analisis/el-constitucionalismo-transformador-y-la-constitucion-chile
[7] In una lettera aperta al Ministro dell’Economia del Cile, il 4 dicembre 2001, Max-Neef scriveva: “Se mi dedico, per esempio, alla depredazione totale di una risorsa naturale, la mia economia cresce mentre lo faccio, ma a costo di diventare più poveri. In realtà, le persone non si rendono conto dell’aberrazione della macroeconomia convenzionale che considera la perdita di ricchezza come un aumento del reddito. Dietro ogni cifra della crescita c’è una storia umana e una storia naturale. Se queste storie sono positive, la crescita è benvenuta, perché è preferibile crescere poco ma crescere bene, piuttosto che crescere tanto ma male”.
[8] Immanuel Kant (1724-1804), pensatore tedesco, utilizzò questo concetto nel campo della filosofia. La filosofia precedente presupponeva che nell'esperienza della conoscenza il soggetto conoscente fosse passivo, che l'oggetto conosciuto influenzasse il soggetto e provocasse in esso una rappresentazione attendibile della realtà. Kant proponeva di ribaltare il rapporto e accettare che nell'esperienza cognitiva sia attivo il soggetto conoscente, che nell'atto della conoscenza il soggetto conoscente modifichi la realtà conosciuta. Quel riconoscimento trasformò radicalmente la filosofia e il mondo stesso. Kant la definì la svolta copernicana., tenendo conto di cosa significasse accettare che la Terra non è il centro dell'Universo, come dimostrato da Niccolò Copernico (1473-1543). Con i Diritti della Natura ci troviamo di fronte ad una situazione simile, anzi di ben maggiore importanza, poiché dobbiamo accettare che gli esseri umani sono Natura e che in essa non esistono specie superiori. Inoltre, l'uomo è la Natura e non ne è escluso. E lei, la Natura, è colei che ci dà il diritto alla nostra esistenza.
[9] Il testo di detta Costituzione può essere consultato all’indirizzo https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf
Bibliografia
- Acosta, A. (2013). El Buen Vivir Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. ICARIA.
- Acosta, A. (2017, dic. 12). ¡Sustentabilidad, cuantas tonterías se dicen en tu nombre! La Línea de Fuego [Revista digital]. https://lalineadefuego.info/sustentabilidad-cuantas-tonterias-se-dicen-en-tu-nombre-por-alberto-acosta/
- Acosta, A. (2019). Construcción constituyente de los Derechos de la Naturaleza – Repasando una historia con mucho futuro. En L. Estupiñán, C. Storini, R. Martínez & F. A. de Carvalho Dantas, La Naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático (pp. 155-206). Universidad Libre, Bogotá / Universidad Andina, Quito. https://uninomadasur.net/?p=2159
- Acosta, A. (2019). La gran transformación desde los barrios – La ciudad, un espacio de emancipación. Rebelión. https://rebelion.org/la-ciudad-un-espacio-de-emancipacion/
- Acosta, A. (2021). Ocio y trabajo, en clave de Buen Vivir. Reflexiones para construir otro futuro. En A. Acosta, A. Pascual García & R. Munck (Eds.), Posdesarrollo. Contexto, contradicciones y futuros (pp. 411-440). Abya-Yala.
- Acosta, A. (2022, marzo 10). Sin derechos de la naturaleza la libertad es una ilusión. El Mostrador. https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/03/10/sin-derechos-de-la-naturaleza-la-libertad-es-una-ilusion/
- Acosta, A. (2022, marzo 17). Chile reconoce los derechos de la Naturaleza. Latinoamérica 21. https://latinoamerica21.com/es/chile-reconoce-los-derechos-de-la-naturaleza/#:~:text=Despu%C3%A9s%20de%20una%20larga%20disputa,y%20forman%20un%20conjunto%20inseparable
- Acosta, A. (2022, abril 26). El agua, un bien común inapropiable – Avanza la Convención Constitucional en Chile. Observatorio Plurinacional de Aguas. (OPLAS). https://oplas.org/sitio/2022/04/26/alberto-acosta-el-agua-bien-comun-inapropiable-un-logro-constitucional/
- Acosta, A. & Brand, U. (2017). Salidas del laberinto capitalista – Decrecimiento y Post-extractivismo, ICARIA. https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Libro-Salidas-del-Laberinto.pdf
- Acosta, A. & Cajas-Guijarro, J. (2020). Buscando fundamentos biocéntricos para una post-economía – Naturaleza, economía y subversión epistémica para la transición. En G. Günther & Meireles, M.(Coords.), Voces Latinoamericanas – Mercantilización de la Naturaleza y Resistencia Social (pp. 23-64). Universidad Autónoma Metropolitana, México.
- Acosta, A., García-Macías & Munck, R. (Eds.). (2021). Posdesarrollo. Contexto, contradicciones y futuros. Abya-Yala. http://www.obela.org/recomendaciones/posdesarrollo-contexto-contradicciones-futuros
- Ávila Santamaría, R. (2022). El constitucionalismo transformador y la Constitución en Chile. Plan V – Hacemos Periodismo. Historias. https://www.planv.com.ec/historias/analisis/el-constitucionalismo-transformador-y-la-constitucion-chile
- Bacilago, J. (Entrevista17.10.2022). “Chile seguirá viviendo una especie de reforma constitucional permanente”. Disponible https://rebelion.org/sergio-grez-chile-seguira-viviendo-una-especie-de-reforma-constitucional-permanente/
- BBC Mundo, Redacción. (2018, enero 18). La soledad, un mal contemporáneo mundial que en Reino Unido ahora es asunto de Estado. BBC News – Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-42723066
- Bosselmann, K. (2021). Ohne Rechte der Natur bleibt Freiheit Illusion. Netzwerk Rechte der Natur https://www.rechte-der-natur.de/de/aktuelles-details/119.html
- Cabanas, E. (2919). Happycracia: Detrás de esta ideología de la felicidad lo que hay es neoliberalismo puro. [Entrevista, 28 de abril del 2019]. Tiempo argentino. https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/happycracia-detras-de-esta-ideologia-de-la-felicidad-lo-que-hay-es-neoliberalismo-puro/
- Constitución Política de la República de Chile, 2022. Propuesta. https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-Definitivo-CPR-2022-Tapas.pdf
- Costa Cordella, E. (2021). Por una Constitución ecológica – Replanteando la relación entre sociedad y Naturaleza. Catalonia.
- Gudynas, E. (2014). Derechos de la Naturaleza: ética biocéntrica y políticas ambientales. Programa Democracia y Transformación Global, Red Peruana por una Globalización con Equidad, CooperAcción, Centro Latino Americano de Ecología, Lima. http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasDerechosNaturalezaLima14r.pdf
- Hervé, D. (2021). Hacia una Constitución Ecológica: Herramientas comparadas para la consagración constitucional de la protección del medio ambiente. FLACSO Chile. https://derecho.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2021/10/3-Hacia-una-Constitucion-Ecologica.pdf
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group II). (2022), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Sixth Assessment Report. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
- Kothari, A., Salleh, A., Escobar, A., Demaria, F. & Acosta, A. (Eds.). (2019). Pluriverse – A Post-Development Dictionary. Tulika Books, India. https://radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse/
- Latour, B. (2007). Nunca fuimos modernos – Ensayo de antropología simétrica. Siglo XXI Editores.
- Lefebvre. H. (1969). El derecho a la ciudad. Ediciones Península. https://monoskop.org/images/3/3c/Lefebvre_Henri_El_derecho_a_la_ciudad.pdf
- Leff, E. (2021). Ecología política, derechos existenciales y diálogo de saberes: horizontes de otros mundos posibles. En P. García Macías, R. Munck, A. Acosta (Coords.), Pensando y actuando fuera de la caja, en clave de post-desarrollo. Contexto, contradicciones y futuros. Co-edición Editorial Glasnevine (Dublín) y Abya Yala (Quito).
- Miguel Trula, E. (2021, feb. 23). Japón ya ha creado un Ministerio de la Soledad, la otra pandemia que nos deja el siglo XXI. Magnet. https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/japon-ha-creado-ministerio-soledad-otra-pandemia-que-nos-deja-siglo-xxi
- ONU, Programa para el Medio Ambiente (2022). Decisión histórica: la ONU declara que el medio ambiente saludable es un derecho humano. https://bit.ly/3M59ebi
- Rodríguez Ibáñez, M. (2018, julio 19). Resignificando la ciudad colonial y extractivista”. Los Muros. https://losmuros.org/194/mario-rodriguez-resignificando-la-ciudad-colonial-y-extractivista/
- Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, and Tokyo. Princeton University Press.
- Solíz Torres, M. F. (2021). La basura como Naturaleza: La basura con derechos. Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/8408
- Stutzin, G. (1984). Un imperativo ecológico: reconocer los Derechos de la Naturaleza. Ambiente y Desarrollo, 1(1), 97-104. https://opsur.org.ar/wp-content/uploads/2010/10/imperativo-ecologico.pdf
- Vásquez Duplat, A. M. (Comp.). (2021). Extractivismo urbano Debates para una construcción colectiva de las ciudades. Prólogo de E. Viale. Fundación Rosa Luxemburgo; Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI); Editorial El Colectivo. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/117217/CONICET_Digital_Nro.13d988da-d8e1-414d-8b05-17ef1326688c_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- VV.AA. (2021). Energías renovables, selvas vaciadas – Expansión de la energía eólica en China y la tala de Balsa en Ecuador . Acción Ecológica, Quito. https://www.accionecologica.org/energias-renovables-selvas-vaciadas-expansion-de-la-energia-eolica-en-china-y-la-tala-de-balsa-en-el-ecuador/